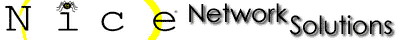|
“Le
donne non hanno paura del diavolo, è il diavolo che deve temere le
donne”
Irene
Salidu,
Su Bisu
PROLOGO
“Se
vi dovesse capitare di andare in Sardegna, non soffermatevi solo alle
zone costiere, dove il mare assume colorazioni smeraldine e turchesi
che neanche le stesse pietre preziose riuscirebbero a eguagliare. Non
cercate le lunghe distese sabbiose che tutti invidiano all’isola,
né le coste rocciose che sprofondano a picco sul mare trasparente e
cristallino.
Se
vi doveste recare in Sardegna, andate nell’entroterra, dove i
popoli sono apparentemente scontrosi, dove i muri raccontano storie e
leggende che ancora affascinano i visitatori. Cercate i paesi
fantasma, che sapranno sussurrarvi segreti, ammirate i nuraghi, che
nascondono storie lontane e indecifrabili anche per chi li ha
classificati. Pensate a una storia mai scritta, che profuma di cisto,
elicriso, pino. Sentite il profumo selvatico nel sottobosco, leggete
ogni piccola scheggia di ossidiana, osservate i cavallini della Giara
o gli asinelli albini dell’Asinara. Entrate in Spagna, in Turchia,
alla corte dei Savoia. Entrate a Roma, visitate le tombe dei giganti,
credendole leggende, o le Domus de Janas, pensandole fantasia. Se vi
capitasse di recarvi in Sardegna, non date nulla per scontato, già
sentito, già visto, perché la Sardegna è una Terra strana, che ti
estirpa il cuore e lo pianta dove non nascono solo vigne, non si
coltivano solo uliveti. La Sardegna è quella terra strana dove, se
lasci il cuore, sai che qualcuno ne avrà cura. È quella strana
terra dove ancora ballano le gonne a pieghe, accanto ai PC, senza
chiedere che le une o l’altro spariscano.
E
il popolo sardo è quello strano popolo che vive in questo mondo, ma
non è di questo mondo, quello strano popolo del quale antiche
leggende narrano che fosse incapace di scrivere, parlare e calcolare…
ed è quel popolo che ha costruito i nuraghi, le tombe dei Giganti, i
Pozzi sacri...
Quello
strano e selvaggio popolo del quale si diceva che avesse paura del
mare…
Sapete,
quello strano popolo di persone basse e piccolette che dicono
proteggesse il Faraone con i suoi Shardana. Già, quello strano
popolo che non è mai stato un solo popolo. La Sardegna è quella
terra dove la donna sembra essere sottomessa agli avvenimenti, alla
famiglia, al padre… ma uno dei primi a essere guidato da una donna
(Eleonora D’Arborea) e regolato da una “costituzione”, La Carta
de Logu de Arborèa, promulgata da una donna.
Se
doveste recarvi in Sardegna, guardate le donne negli occhi: vedrete
tante Leila, Luisa, Bianca… Che non si arrendono, ma cercano sempre
nuovi modi per lottare. E quando sentirete la cantilena della loro
voce, non abbandonatevi ai suoni. Potrebbero essere le voci delle
sirene di Ulisse”.
Il
romanzo di Irene Salidu ci porta nell'entroterra della Sardegna,
un'isola ricca di tesori e misteri stratificati nei millenni. I miti
e le leggende sono conservati in ogni pietra, ramo, cuore dei suoi
abitanti. La memoria della tradizione è viva e congiunge il presente
e il passato. Allo stesso modo il reale e l'immaginario si fondono in
un sogno che abbraccia credenza e rito, la vita e la morte. E questo
legame è possibile solo attraverso la figura della donna o delle
donne, Leila, Bianca, Luisa, personificazioni
di quella cultura popolare più profonda che mai che è cresciuta,
latente e nascosta, segreto e scrigno di una sapienza mai
dimenticata, collezione di pratiche alchemico-magiche,
sperimentazione e superstizione, culto e rispetto per le Janas.
Queste
figure rappresentano una tradizione secolare nella storia sarda,
curatrici attraverso erbe medicinali, accompagnatrici nel parto e
nell'eterno riposo. Nutrice e accabadora ,
la Jana rappresenta una figura-ombra presente nella comunità,
difesa, protetta e rispettata, come aiutante della famiglia nei
momenti di massima propensione verso la magia e il mistero della vita
e della morte.
La
narrazione si snoda attraverso una serie di capitoli dedicati ai vari
personaggi, come concatenazione di eventi che trasferiscono il
lettore dal piano reale all'onirico attraverso una trance mistica che
oltrepassa il tempo e lo spazio abbracciando verità e finzione.
La
scrittura, densa di particolari, riesce a far sentire al lettore ogni
suono, passo, profumo, respiro, sensazione. Irene porta il lettore
dentro la narrazione. Lo spettatore viene trasformato in testimone di
una polifonia sinestetica che lo investe come per effetto
dell'incantesimo dell'autrice.
LE
JANAS
Tutta
la narrazione porta bagliori di luce sul mito delle Janas, fate a
cavallo tra l'umano e il divino, esperte nell'uso delle erbe
medicinali, guaritrici abili nella preparazione di unguenti naturali.
La radice del nome è un filo conduttore con Giano, dio romano
bifronte, porta tra il passato e il futuro, corrispondenza con la
parola che in sardo significa proprio “porta”, ove le janua sono
collegamenti tra mondi. Giano, consorte di Diana, era l'inizio di
ogni cosa, invocato nei sacrifici, divinità per risolvere le crisi,
con un terzo volto invisibile che guarda al presente nella sua
inafferrabilità.
Le
Janas erano donne minute in grado di vivere in luoghi angusti, grotte
di piccole dimensioni, vestite di pelli, che si nutrivano
di frutta selvatica in mezzo ai boschi. La leggenda vuole che queste
creature avessero il dono della profezia che determinava il destino
degli uomini, tessitrici della vita e della morte, eco della
tradizione delle tre parche.
La
loro presenza celata era visibile solo di notte, quando uscivano
evitando la luce diurna per paura che le annerisse. Dopo la
mezzanotte cucivano e ricamavano: abili tessitrici, ma anche custodi
dei segreti del mare. Sono cogas
e strias,
eco del passato intriso di sciamanismo di questa terra.
Tutta
l'Italia meridionale e insulare è ricca
di questo folklore: basti pensare alle celebri Janare di Benevento,
tradizione dell'Irpinia, per le quali l'intreccio dei fili nei
tessuti come nella cucina era un rituale. L'estasi mistica avveniva
intorno al noce nei pressi del fiume Sabato.
Per
proteggersi dalla loro venuta, gli abitanti erano soliti porre una
scopa di saggina davanti alla porta così la strega era costretta a
perdere tempo per contarne i fili intrattenendosi fino all'alba. Per
lo stesso motivo accanto alle aperture come porte e finestre si
metteva il sale affinché la strega si attardasse
nel
contarne i granelli. Queste dame oscure viaggiavano su scope o
rubavano i cavalli dalle stalle intrecciandone le criniere.
Quel
nome Jana o Janara evoca la dea Diana (Dianare, seguaci di Diana): da
questa
nasce la
scia di donne forti, indipendenti, cacciatrici, eredi di Artemide
proprio come Leila nel romanzo che si procaccia il nutrimento
realizzando un arco. Diana, inoltre, era opposta ad Apollo come la
luna al sole, divinità bianca, pura come una vergine, ma anche dea
della porta eterna che congiungeva gli individui alla madre terra
dopo la morte. La cultura originaria deriva da Iside: basti pensare
agli obelischi egizi nei punti strategici di Benevento e
al
tempio a lei dedicato in età romana sotto Domiziano.
Tutte
le tradizioni pagane, demonizzate dal cristianesimo, si
cementificarono con la dominazione longobarda e restarono come parte
integrante, ma nascosta, della cultura popolare
attraversando il Medioevo fino ai giorni nostri.
Le
figure femminili presentate dall'autrice vivono in un periodo in cui
le streghe sono accettate e quel folklore è diventato un mestiere:
l'erborista, la farmacista, una Bianca del romanzo che eredita la
tradizione e la tramanda in modo ufficiale.
Il
punto di congiunzione tra i due mondi, reale e fantastico, è dato
dalla danza, trance che trasporta Leila in una compenetrazione tra
umano e terreno, unione mistica con la natura, espressione di fusione
e fecondità tra fuoco sacro e pioggia che ricorda la Tempesta
di Giorgione.
“Sono
decenni che la Scienza ci dice che noi utilizziamo solo una parte
minima delle nostre risorse mentali. Mai una voce, però, si è
levata da quel settore, una voce che dica come fare, come riuscire ad
attingere alla pienezza regale del nostro intelletto; mai un iter
sembra essere stato tracciato verso una metodologia dell’Eureka,
mentre ci sono corpose vie per entrare nei fiotti dell’intuizioni.
Gli uomini dell’evo arcaico scoprirono, in una corretta prassi
psichedelica, la via all’utilizzo della profonda trance che ne
conseguiva per elevare lo sguardo dell’intelletto, riuscendo così
non solo a rispondere a tutte le loro necessità pratiche, ma anche a
riappropriarsi del senso stesso delle loro esistenze, in intima e
profonda connessione con il Tutto” .
Proprio
da questi rituali sono nate la pizzica salentina e la tarantella di
ampia diffusione in tutto il Mezzogiorno. Ancora nel contemporaneo
gruppi musicali come gli Alla
Bua
hanno rappresentato la pizzica U
rusciu te lu mare/Lu rusciu de lu mare
come momento di estasi e tarantismo in una sorta di possessione
demoniaca.
“Lu
rusciu de lu mare 1999
'Na
sira ieu passai te le padule,
e
'ntisi le ranocchiule cantare,
e
'ntisi le ranocchiule cantare.
A
una a una ieu le sintia cantare,
ca me pariane lu rusciu te lu
mare,
ca me pariane lu rusciu te lu mare.
Lu
rusciu te lu mare è mutu forte,
la fija te lu re se tae alla
morte,
la fija te lu re se tae alla morte.
Iddhra
se tae alla morte e ieu alla vita,
la fija te lu re sta se
marita,
la fija te lu re sta se marita.
Iddhra
sta se marita e ieu me nzuru,
la fija te lu re me tae nu
fiuru,
la fija te lu re me tae nu fiuru.
Iddhra
me tae nu fiuru e ieu na palma,
la fija te lu re se 'ndeae alla
Spagna,
la fija te lu re se 'ndeae alla Spagna.
Iddhra
se 'ndeae alla Spagna e ieu 'n Turchia,
la fija te lu re la zita
mia,
la fija te lu re la zita mia.
E
vola vola vola palomba vola,
e vola vola vola palomba mia,
ca
ieu lu core meu,
ca ieu lu core meu,
ca ieu lu core meu te
l'aggiu dare”
.
Si
pensi a Georges Laprassede “La
transe è innanzitutto un comportamento motorio diverso dal solito.
Per l’osservatore occidentale, essa è un sintomo psicopatico. Ma
altrove, razionalmente, nella cultura religiosa e popolare, essa è o
l’estasi del corpo, oppure l’intervento di un dio, di uno
spirito, di un “demone” che cavalca il corpo dei posseduti. E’
un fenomeno normale la cui base è neurofisiologica, corporale. Su
questa base, ogni cultura impone un contenuto ed un significato. Di
più, la cultura, e più precisamente l’immaginario sociale, può
provocare la transe, può mettere il corpo in transe”
. Si riferisce, in particolare, all'evoluzione del culto di Dioniso
come fenomeno sociale del rave.
LE
DOMUS DE JANAS O CASE DELLE FATE
“Ci
sono buchi in Sardegna che sono case di fate, morti che sono colpe di
donne vampiro, fumi sacri che curano i cattivi sogni e acque segrete
dove la luna specchiandosi rivela il futuro e i suoi inganni. C’è
una Sardegna come questa, o davanti ai camini si racconta che ci sia,
che poi è la stessa cosa, perché in una terra dove il silenzio è
ancora il dialetto più parlato, le parole sono luoghi più dei
luoghi stessi, e generano mondi. Qui esiste tutto ciò che viene
raccontato, e quello che viene taciuto esiste perché un giorno
qualcuno lo racconterà.”
Michela Murgia
In
terra sarda la tradizione delle Janas ha un corrispettivo
architettonico che rappresenta un patrimonio di pregevole valore: le
Domus de Janas o Case delle Fate rappresentano il 61mo sito UNESCO
italiano, assegnato il 12 luglio 2025. Il complesso è costituito da
17 sepolture e necropoli ipogeiche risalenti al V-III millennio a. C.
tra il Neolitico Medio e l'Età del Bronzo:
Necropoli
di Anghelu Ruju (Alghero)
Necropoli
di Puttu Codinu (Villanova Monteleone)
Necropoli
di Monte Siseri / S’Incantu (Putifigari)
Necropoli
di Mesu e Montes (Ossi)
Necropoli
di Su Crucifissu Mannu (Porto Torres)
Domus
de Janas dell’Orto del Beneficio Parrocchiale (Sennori)
Domus
de Janas della Roccia dell’Elefante (Castelsardo)
Parco
dei Petroglifi (Cheremule)
Necropoli
di Sant’Andrea Priu (Bonorva)
Necropoli
di Sa Pala Larga (Bonorva)
Necropoli
di Sos Furrighesos (Anela)
Necropoli
di Ispiluncas (Sedilo)
Necropoli
di Mandras / Mrandas (Ardauli)
Necropoli
di Brodu (Oniferi)
Necropoli
di Istevene (Mamoiada)
Parco
Archeologico di Pranu Mutteddu (Goni)
Necropoli
di Montessu (Villaperuccio)
Le
costruzioni
riflettono
pratiche funerarie e credenze spirituali della Sardegna. “Queste
strutture presentano planimetrie complesse, decorazioni simboliche e
motivi figurativi che testimoniano la trasformazione del rapporto tra
i vivi e i morti in una società in transizione verso forme più
complesse di organizzazione sociale. Rappresentano la più ampia e
ricca manifestazione di architettura funeraria ipogea nel
Mediterraneo occidentale, esemplificando un fenomeno attestato da
circa 3.500 ipogei sparsi in tutta l’Isola, in particolare nella
parte centro-settentrionale, verosimilmente associati a insediamenti
e villaggi, oltre che a luoghi di culto”.
La
loro particolarità sta nella struttura sotterranea che riconduce il
defunto alla terra madre come in un ouroboros
del ciclo vitale. Come la dea Diana riaccompagnava l'uomo attraverso
la morte per ricongiungersi all'origine, così le Janas e le Janare
irpine erano duplici figure, tanto nutrici quanto accabadora.
All'interno delle domus, spesso opposta all'ingresso, è raffigurata
una porta per il passaggio ideale del defunto nell'aldilà come
purificazione e ritorno alla verginità.
La
tradizione letteraria antica e classica è forte in terra sarda: già
in Plauto una partoriente si affidava nel momento delle doglie a
Lucina; in Varrone Lucina o Luchina sovrintendeva al flusso
mestruale; in Catullo le donne in travaglio chiamavano Giuno Lucina.
Ecco il mito delle Janas, donne che consegnavano le spoglie alla
Mater Luna. In Sardegna le donne nubili sono chiamate Ba-Janas o
Baca-Dias, ovvero Baccanti di Diana o della luna.
Le
costruzioni rappresentano ideali capanne, specchio delle abitazioni
quotidiane, dove si ritrovano iscrizioni delle antiche civiltà e
decorazioni mistiche spiraliformi.
La
tradizione millenaria della Sardegna presenta una stratificazione di
storia, mito, cultura e leggenda tramandata nel tempo attraverso il
suo popolo. Quelle donne descritte da Irene Salidu sono le
depositarie di una sapienza che ha le sue radici nelle case delle
fate, nei nuraghi, nei pozzi, nelle tombe dei giganti, nel rito
tramandato di generazione in generazione di chi non ha mai
dimenticato le proprie radici.
“Scheda
Libro SU BISU (Il Sogno)
AUTORE
IRENE SALIDU
TITOLO
SU BISU – Il sogno
CASA
EDITRICE AUREA NOX
ANNO
DI PUBBLICAZIONE 2024
ISBN
9791281625600
PAGINE
129
Genere:
romanzo
Luogo
e tempo della storia: Centro Sardegna. Dal 1800 a.C circa fino al XX
secolo
Trama:
Il romanzo è la narrazione storica e mitica intessuta su un sogno di
una delle donne protagoniste. Attraverso il mondo onirico che si
intreccia a quello reale, sono narrate le tradizioni, raccontati i
miti, descritti i luoghi della zona più misteriosa della Sardegna
(la Barbagia nuorese). Il cammino delle donne protagoniste parte
dalla civiltà nuragica, attraversa gli anni ’30, si conclude
nell’epoca attuale.
Personaggi:
tutte le donne raccontate sono da considerarsi come personaggi
principali.
Leila:
la donna che viaggia nel tempo attraverso i sogni.
Luisa:
la donna della medicina, ostetrica e Accabadora del paese.
Giuseppina:
madre che rappresenta il matriarcato celato.
Bianca:
colei che spezza la catena della tradizione.
Tutti
gli altri personaggi: Bachisio, il servo pastore che rappresenta il
tramite tra Leila e il mondo reale.
Ambientazione
storica: Barbagia di Orgosolo, dal 1800 a.C. fino al XX secolo.
Simbolismo
e significato: la storia della Sardegna descritta in questo romanzo è
un insieme di reale e fantastico, ed è attraverso questo canale, che
viene rappresentata la figura-perno della donna nelle diverse epoche.
Su Bisu, che significa “il sogno” in sardo, è molto più di una
semplice narrazione storica o mitica. Si tratta di una combinazione
di suggestioni sull’era nuragica e sull’apporto che le donne
sarde, figure centrali nelle comunità rurali e nelle famiglie, hanno
custodito per secoli, con il loro sapere antico, tramandato oralmente
di generazione in generazione tra medicina popolare, magia e
spiritualità. Il romanzo stesso fa parte di quelle peculiarità
delle donne sarde, intriso di spiritualità, di simbolismi, di
femminilità, abnegazione, libertà, forza”
NOTE
BIBLIOGRAFIA
ARRAS 2011
Maria Antonella ARRAS,
Accabadora
e la sacralità del femminino. Riti e credenze nella tradizione
popolare sarda, Palermo,
Isola Palma, 2011.
BUCARELLI
- LUBRANO 2003
Alessandro
BUCARELLI, Carlo LUBRANO, Eutanasia
ante litteram in Sardegna. Sa femmina accabadora. Usi, costumi e
tradizioni attorno alla morte in Sardegna, Cagliari,
Scuola
Sarda,
2003.
CITTERIO - SALIDU 2020
Arnaldo CITTERIO, Irene
SALIDU, Briciole e
Fiabole, 2020.
EAGLE 2007
Gipsy EAGLE, Psichedelia.
Un ponte verso
l’infinità,
Roma, Venexia
Editrice,
2007.
LAPASSADE 1980
Georges LAPASSADE, Dallo
sciamano al raver,
(Essai sur la transe), Mondadori Milano 1980.
MORAVETTI 2023
Alberto MORAVETTI, Domus
de janas. Arte e religione nelle tombe ipogeiche della Sardegna
preistorica, Sassari, Carlo
Delfino Editore,
2023.
MURGIA 2008
Michela MURGIA, Viaggio
in Sardegna,
Torino, Einaudi, 2008.
MURGIA 2009
EAD., Accabadora,
Torino,
Einaudi,
2009.
PITZALIS 2025
Valentino PITZALIS, Il
respiro delle Janas: Viaggio tra leggende, superstizioni e misteri
della Sardegna antica, Cagliari,
Kindle Book, 2025.
ROMANAZZI 2009
Andrea ROMANAZZI, Guida
alle streghe in Italia,
Roma, Venexia editrice,
2009.
SALIDU 2003
Irene SALIDU, La
valle delle rune:OI,
Milano, Aureanox,
2023.
EAD, Rune
di Maggio,
Aureanox,
Milano 2019.
SALIDU
2020
EAD, Lei,
Milano,
Aureanox,
2020.
SALIDU 2024
EAD, Se
"salgo su" una sedia grido: "Capitano! Mio Capitano!",
Milano,
Aureanox,
2024.
SALIDU 2024
EAD, Su
Bisu. Il sogno,
Milano, Aureanox, 2024.
SERRA 2015
Pierluigi SERRA, Maghe
e streghe di Sardegna.
Dalla
fata di Mannorri alla strega di Guasila: le leggendarie custodi dei
segreti dell’isola,
Roma, Newton
Compton, 2015.
TURCHI 2007
Dolores TURCHI, Lo
sciamanesimo in Sardegna, Roma,
Newton Compton, 2007.
SITOGRAFIA
ALLA BUA 2006
ALLA BUA, Lu
rusciu de lu mare,
video https://youtu.be/0jryWN38HfQ?si=GH8vTDygZIKhzZoM
GOODREADS 2023
La valle delle rune Oi,
La
valle delle rune : OI (Italian Edition) by Irene Salidu | Goodreads,
2023
LEZZI FIORENTINO 2024
Maria Teresa Lezzi Fiorentino,
La
valle delle rune:OI, Irene Salidu, “Il
mondo incantato dei libri”, 2024 La
valle delle rune:OI, Irene Salidu
UNESCO 2025
La
tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna – Le domus de
janas,
16/07/2025, “UNESCO.it”, La
tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna - Le domus de
janas - Unesco Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco
|