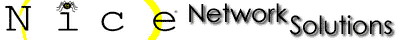|
1)
Un percorso virtuoso dell'amministrazione comunale
(di
Cristina Mochi)
La
collocazione delle vele del Palazzo Altoviti (Fig. 1)
 Fig. 1 – Raffaello Sanzio, Ritratto di Bindo Altoviti
Fig. 1 – Raffaello Sanzio, Ritratto di Bindo Altoviti
National Gallery, Washington (Free Open Access)
Foto cortesia di Cristina Mochi
all'interno della Sala ora detta delle
vele
della Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma, conclude un
percorso d'eccezione iniziato tanti anni fa e documentato dalle
carte conservate in prevalenza all'Archivio di Stato e all'Archivio
Capitolino di Roma. Lo sforzo è stato grande ma più forte
l'intenzione di molti, a cui vanno i nostri ringraziamenti: la
Soprintendenza BBCC in risposta alla nota del Comune di Roma prot. n.
60665-A del 14/11/2024 ‹‹concorda
con la necessità e l'opportunità di riposizionare le volte,
prende atto delle scelte sul riposizionamento delle volte che è
frutto -come delucidato in sede di sopralluogo- di necessità
ambientali e logistiche (presenza delle finestre, del portone di
ingresso, umidità...) nonostante tale sistemazione non rispecchi
appieno la disposizione dell'insieme originario (volte a botte) e
renda difficile la comprensione delle relazioni tra gli elementi››.
Capita
talvolta che gli interessi delle istituzioni, qui in
primis
del Comune di Roma, e in particolare della Direzione della Scuola di
Arte e Mestieri, si incontrino con quelli di studiosi impegnati in
ricerche tangenti: il caso ha così voluto che tre docenti della
Scuola di Arti Ornamentali (corso di Conservazione e Restauro- Grazia
del Giudice, Simona Irrera, Cristina Mochi) avessero iniziato da
tempo a indagare le ragioni storiche delle vele, attraverso ricerche
condotte secondo declinazioni specifiche dettate dalle diverse
competenze di studio delle docenti stesse. Ne è nato un saggio a tre
voci. Il restauro delle vele, dei sottarchi e delle lunette era stato
avviato già anni fa, e il nuovo programma di riallestimento è stato
affiancato da un progetto di ricerca (AD OPERA) che ha visto la
rilettura della storia delle Scuole di Arte e Mestieri di Roma e la
revisione totale della bibliografia passata. A questo si è aggiunto
lo studio dei manufatti, della loro collocazione originaria, e di una
possibile strada attributiva attraverso le carte d'archivio. Tali
spunti non hanno però rappresentato l'unico obiettivo dal momento
che, tra scritti e documenti inediti, la storia si è arricchita di
intrecci più complessi, di importanti rettifiche e di argomenti
finora
inevasi.
(di
Cristina Mochi)
2)
LE SCUOLE DI ARTI E MESTIERI DI ROMA
(di
Simona Irrera)
Nel
1871, Roma diventa la Capitale del Regno d'Italia. Questo evento
storico porta cambiamenti radicali, nuove istituzioni scolastiche e
un nuovo assetto urbanistico con demolizioni, ricostruzioni ed
edificazione d'interi quartieri, ad esempio Testaccio, Esquilino,
Prati ecc. L'epoca storica in cui questi eventi avvengono è
caratterizzata dalla rivoluzione industriale in cui la produzione
manifatturiera muta in modo drastico e irreversibile, l'artigianato
diviene produzione industriale in serie. La nuova realtà europea
richiede lavoratori preparati nel disegno tecnico e in tutte quelle
competenze necessarie a nutrire un sistema unitario industriale
nascente in Italia. All'istruzione pubblica è richiesto di
preparare la classe dirigente nei licei e la classe operaia nelle
scuole tecniche e professionali. A Roma, il nuovo stato italiano
trova una realtà educativa in cui le famiglie hanno «la preziosa
abitudine di inviare i figli a scuola»
,
questo è il fondamento dell'istituzione post-unitaria delle scuole
elementari e trova radici nelle scuole pontificie preunitarie.
Le
scuole nello Stato Pontificio nell'Ottocento prima dell'Unione
d'Italia si distribuivano in religiose, quindi rette da ordini,
congregazioni o confraternite - ad esempio Gesuiti e Scolopi – e
private, gestite da maestri e maestre regionarie .
Le scuole regionarie sono private e a pagamento, centralizzate con
dei responsabili dipendenti direttamente dal Municipio. A metà del
Settecento perdono il monopolio dell'istruzione di base e diventano
dipendenti del Rettore dell'Università La Sapienza .
Nel 1655, Papa Alessandro VII Chigi istituisce scuole regionarie di
Maestre Pie dipendenti dalle elemosiniere del Papa con sede nel rione
Monti, che si dedicano all'istruzione delle giovani donne.
Nel 1688 le Orsoline – fondate da Sant'Angela Merici nel 1535 –
arrivano a Roma e fondano una scuola in via del Corso per opera della
duchessa Lucia Martinozzi .
Le scuole religiose nascono sulla spinta dei propositi sanciti nel
Concilio di Trento 1545-1563, in risposta alla riforma Luterana e
alla necessità di insegnare i principi della religione e dei Padri
della Chiesa sono anticipate nel concilio Lateranense V nel 1512-1517
ma trovano pieno compimento solo dopo il Concilio di Trento ad opera
di alcune significative personalità quali Carlo Borromeo e Ignazio
di Loyola.
Nel
1551 Ignazio di Loyola fonda il Collegio Romano, prima scuola della
Compagnia del Gesù o gesuita a Roma. Nel 1556 sono riconosciuti i
titoli accademici da parte di Paolo IV Carafa. La scuola conferiva
tutti i livelli da quello elementare fino agli studi universitari,
incluso il dottorato, accogliendo allievi che sapevano leggere e
scrivere ,
nel tempo specializzandosi solo nelle scuole secondarie e negli studi
superiori. Sebbene il fulcro dell'istruzione impartita sia il
catechismo, nelle scuole gesuite s'insegnano anche le materie
letterarie e scientifiche, in particolare la teologia e la filosofia
.
Il collegio romano s'ispira a una pedagogia affine a quella
universitaria. Le scuole gesuite saranno presenti a Roma fino alla
soppressione dell'ordine nel 1773. L'ordine rientra in possesso
delle proprie istituzioni nel 1824 per concessione di Papa Leone XII
Della Genga .
L'edificio del Collegio Romano è confiscato da parte dello Stato
italiano nel 1871 e diventa la sede del Liceo ginnasio Ennio Quirino
Visconti, primo liceo di Roma Capitale.
Nel
1560 Marco de Sadis Cusani fonda a Roma una scuola di dottrina
cristiana presso Santa Apollinare. Papa Pio V Carafa promuove questa
istituzione, mettendo in pratica i principi sanciti dal concilio di
Trento, con una bolla nel 1567. Questa iniziativa alimenta la nascita
delle confraternite della dottrina cristiana (anche dette dei
dottrinari) e, dall'unione di ecclesiastici e laici, deriva la
congregazione della dottrina cristiana che, infine, confluisce
nell'istituzione francese di Cesare de Bus attiva già dal 1593 nel
campo dell'istruzione del catechismo. Papa Gregorio XIII
Boncompagni Ludovisi nel 1575 assegna la chiesa di Sant'Agata nel
Rione Trastevere ai sacerdoti dottrinari allo scopo di insegnare il
catechismo. Questi, prendono il nome di Agatisti e mantengono
carattere secolare. Nel 1621 nelle scuole dei padri dottrinari
s'insegna la grammatica, la retorica, la filosofia e la matematica
oltre alla teologia e alla dottrina cattolica .
Nel 1726 Benedetto XIII Orsini affida alla Congregazione dei Padri
della Dottrina Cristiana la chiesa di Santa Maria in Monticelli nel
rione Regola corrispondente a piazza San Paolo della Regola e, in
parte, alla sede attuale della Curia dell'ordine .
Tale concessione include l'oratorio di Sant'Andrea della Valle
con una rendita a sovvenzione dell'apertura di altre scuole, questo
permette alle scuole di essere accessibili gratuitamente .
Nel 1747, per opera di Papa Benedetto XIV Lambertini la
congregazione si fonde con l'omonima società attiva in Sant'Agata
.
Alla metà
dell'Ottocento, i padri dottrinari hanno cinque scuole attive, due
presso Sant'Agata in cui s'insegnano il catechismo, lettura,
scrittura e il latino (i rudimenti), tre scuole sono presso Santa
Maria in Monticelli in cui s'insegna il latino (classi avanzate) e
le lettere umane. In totale, studiano presso questi istituti 310
scolari, le scuole sono gratuite e sono organizzate in tre ore la
mattina e tre ore nel pomeriggio, la messa è prevista tutti i giorni
la mattina .
Nel
1597 San Giuseppe Calasanzio fonda le scuole Pie (dette anche
Piariste o degli Scolopi) a Santa Dorotea a Trastevere
.
Questa è la prima scuola gratuita a Roma per l'istruzione «de‘più
poveri del popolo»
.
Calasanzio riceve il sostegno di Papa Clemente VIII e prosegue
estendendo la sua opera anche a San Pantaleo e San Loreno in Borgo .
Le scuole avevano una vocazione popolare ed elementare ma
svilupperanno anche l'istruzione secondaria .
Nelle scuole del Calasanzio si davano gratuitamente agli studenti la
carta, la penna e l'inchiostro. Lo stesso Calasanzio aveva scelto
un banco-scrittoio dove gli allievi potessero esercitarsi e
raccomandato la disposizione dei banchi in modo che gli insegnanti
potessero agevolmente girare e avvicinarsi agli studenti .
Nella
Chiesa, e quindi nelle iniziative degli istituti religiosi che
aprivano scuole, il primo fine era preparare i giovani verso la
dottrina, insegnare quindi i rudimenti della religione, in supporto o
in sostituzione dei genitori in uno spirito squisitamente
controriformista. Alcune istituzioni nascono con lo scopo didattico
come principio fondante mentre altre si adattano ai bisogni della
società in cui sono collocate. Molti istituti religiosi, fino alla
Rivoluzione francese sono gratuiti, ma la perdita dei beni che
caratterizza gli eventi storici che si susseguono in quegli anni
porta alla necessità di richiedere un pagamento, e ciò comporta
l'esclusione dei ceti più poveri 18.
L'apertura
di scuole gratuite porta a un conflitto - una «gagliarda lotta»
la definisce Moroni
17 -
con i maestri regionari, le cui scuole erano a pagamento. Questi,
ritenevano di avere l'esclusiva dell'istruzione romana
elementare, inoltre vi era, al tempo, diffidenza verso un'istituzione
che non discriminava le classi sociali .
Nel 1702 i Fratelli delle Scuole Cristiane di Giovanni Battista De La
Salle fondano una comunità a Roma e nel 1725 ottengono da Benedetto
XIII l'approvazione per aprire case in varie nazioni nel mondo .
Nel 1793 ricevono da papa Pio VI una scuola gratuita per l'istruzione
popolare in San Salvatore in Lauro .
Nel 1823 in queste scuole, s'insegna a leggere, scrivere,
l'aritmetica oltre alle basi di geometria, meccanica e architettura
civile .
Nel
1587 Papa Sisto V Peretti fonda un ospizio dei mendicanti, la
struttura, opera dell'architetto Domenico Fontana, includeva una
scuola in cui s'insegnava a leggere, scrivere, oltre ad arte per i
ragazzi e cucito per le ragazze .
Quest'opera pia fu trasferita nel XVIII secolo nell'Ospizio
Apostolico di San Michele che fu istituito da Papa Innocenzo XI
Odescalchi, con sede a Trastevere, per rispondere all'emergenza
sociale e accogliere giovani in condizione di fragilità. Questi
giovani erano avviati alle pratiche artistiche da una scuola di arti
e mestieri interna .
La
struttura, al contempo assistenziale per anziani ed educativa per i
giovani, con l'avviamento a una professione, era famosa soprattutto
per gli arazzi (Arazzeria Albani, attiva fino al 1926) e includeva
l'ospizio per mendicanti come in origine, oltre a un carcere
minorile e un altro femminile.
Nel
1853 nel Giornale di Roma è menzionata una scuola di disegno .
L'origine di questa istituzione è da far risalire all'iniziativa
di alcuni lavoratori che nel 1539 abbandonano la pre-esistente
Università dei muratori, corporazione di mestiere che includeva i
lavoratori del legno. Papa Paolo III trasforma questo nuovo gruppo in
confraternita, e nel 1540 Gregorio XIII la eleva ad arciconfraternita
intitolata San Giuseppe dei falegnami. Il gruppo di lavoratori
ottiene la Chiesa di San Pietro al carcere Mamertino e, ivi,
costruisce, per necessità logistiche, la chiesa di San Giuseppe dei
falegnami .
Nel
1819 un intagliatore del legno romano, Giacomo Casoglio, desidera
istruire i giovani lavoratori e apre a Roma le "scuole
notturne", in cui si studia religione e s'impara a leggere,
scrivere e far di conto .
Questa iniziativa ebbe successo e se ne interessò il cerimoniere
pontificio Mons. Giannoli che gli assegnò un oratorio notturno
presso San Nicola degli Incoronati. La scuola sopravvisse al suo
fondatore, scomparso nel 1823, e sotto la guida dei sacerdoti di San
Nicola, e grazie all'attività dell'avvocato Michele Gigli, trovò
altre sedi e benefattori. Gigli aprì una scuola notturna in San
Salvatore in Lauro nel 1830, poi un'altra in Borgo nel 1835. Queste
iniziative educative furono proseguite da San Vincenzo Pallotti,
istitutore dell'apostolato cattolico. Nel 1841 viene pubblicato
l'Ordinamento
del pio istituto delle scuole notturne di religione pe' poveri
artigiani in Roma,
la società dipendeva dal cardinale vicario e si occupava di dare
un'educazione di base nelle ore serali e nei giorni festivi. Nel
1842 la società ha otto scuole per circa mille allievi; in alcune di
queste scuole, oltre la dottrina, l'aritmetica e l'ortografia,
s'insegna nel quarto anno anche disegno lineare, d'ornato e
geometria applicate alle arti e i migliori allievi sono premiati con
medaglie .
Nel 1847, aprono cinque scuole notturne ,
fra queste, il 22 luglio 1847 è inaugurata una scuola notturna per
giovani a piazza Santa Maria in Monticelli nel rione Regola ,
dove erano attivi i Padri Dottrinari.
Nel
1824 Papa Leone XII riordina l'istruzione pubblica nello Stato
Pontificio istituendo la Congregazione degli studi, formula il
regolamento delle scuole private elementari nel 1825 imponendo gli
insegnamenti della dottrina cristiana, la lettura e la scrittura, la
lingua latina, l'aritmetica, la calligrafia, la geografia, la
storia; stabilisce che i maestri regionari debbano essere approvati
con una patente annuale e istituisce le scuole parrocchiali gratuite
per il catechismo e per imparare a leggere e scrivere. In questo
momento ci sono 60 scuole regionarie distribuite nei vari rioni .
Un'ulteriore rivoluzione segue la Repubblica romana, in questo
periodo di restaurazione pontificia, Papa Pio IX ordina un rapporto
sulle istituzioni scolastiche romane. In questo documento si
evidenzia come fosse diffuso nelle tredici scuole notturne attive nel
1851 l'insegnamento del disegno e dell'architettura con lo scopo
di avvicinare gli allievi all'arte, quest'attività è ritenuta
pericolosa dall'autorità pontificia e, negli anni successivi
ridotta al solo insegnamento della religione da parte degli
ecclesiastici, la quarta classe, d'indirizzo professionale, è
abolita nel 1858 e i maestri laici gradualmente esclusi
dall'insegnamento .
Nel
1850 i Fratelli di san Giuseppe di Francia aprono il Pio Istituto
Artistico a Santa Prisca che si trasferisce presso la Vigna Pia fuori
porta Portese in uno stabilimento agricolo sotto Papa Pio IX
Mastai-Ferretti il 1° novembre 1851 .
L'istituzione era un orfanotrofio di carità e un istituto agrario
in cui i giovani erano istruiti all'arte agraria, ora è sede di un
centro sportivo diretto dalla Congregazione della Sacra Famiglia di
Bergamo per volere di Papa Benedetto XV.
A
questa capillare offerta didattica di base si affiancano e crescono
floride accademie, associazioni e confraternite, per iniziativa di
artisti e religiosi, principalmente devote all'arte. Nel 1481, per
opera di Desiderio de Adiutorio, nasce la Pontificia Insigne
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon,
compagnia di artisti devoti alle reliquie della Terra Santa.
L'intento era di occuparsi della conservazione e del culto di tali
reperti, la congregazione riceverà nel 1543 il riconoscimento papale
per opera di Papa Paolo III Farnese .
I maggiori artisti virtuosi erano associati e fra questi ricordiamo
Pietro da Cortona, Perin del Vaga, Francesco Borromini, Diego
Velazquez, Luigi Vanvitelli, Giuseppe Valadier, Antonio Canova e
Federico Zuccari .
L'istituzione è sopravvissuta agli eventi storici nei secoli ed è
tuttora attiva .
Nel
1593 Federico Zuccari fonda l'Accademia Nazionale di San Luca con
l'intento di insegnare le belle arti e facendo riferimento alla
precedente Università dei Pittori, Miniatori e Ricamatori .
Questa era una corporazione di mestiere sotto Sisto IV Della Rovere
nel 1478 e già nel 1577, sotto Gregorio XIII, si era sancito il
passaggio da Università ad Accademia delle Arti della Pittura, della
Scultura e del Disegno; il Breve del 1577 riporta l'attività di
alloggio per tre studenti giovani venuti a Roma per studiare Disegno.
La fondazione dell'accademia si realizzerà formalmente grazie a
Zuccari, primo direttore, detto principe, il 14 novembre 1593 con la
prima sessione accademica. I principi che hanno nel tempo ricoperto
il ruolo di direttore sono eminenti artisti quali, Gian Lorenzo
Bernini, Domenichino, Pietro da Cortona, Bertel Alberto Thorvaldsen e
Antonio Canova. Gli studenti migliori ricevevano premi, fra questi,
ricordiamo il concorso Clementino (da Clemente XI) nel 1702 .
Zuccari esprime il proprio progetto educativo, in anni che precedono
la fondazione dell'accademia romana, durante il suo soggiorno a
Firenze e in riferimento all'accademia del disegno fiorentina, egli
pone la base delle arti nel disegno dal vero che diventa la materia
da insegnare ai giovani artisti .
L'accademia si distaccava dalle corporazioni dette Università e
mirava all'arte alta, gli accademici non potevano avere bottega e,
per alcuni anni, il regolamento includeva il divieto di tenere classi
private di disegno dal vero. Ciononostante, nel 1715 furono
autorizzate classi private tenute da accademici di San Luca, e
queste, quindi, fiorirono a Roma in seguito .
Nel 1754, Papa Benedetto XIV fonda in Campidoglio una Scuola del Nudo
pubblica e gratuita, gestita dall'Accademia di San Luca, questa
rappresentava una novità poiché gli studi accademici si proponevano
di elevare l'artigianato ad arte. Nel 1810, durante il periodo
Napoleonico, nasce la Scuola delle Belle Arti, in analogia alla
realtà parigina, anch'essa pubblica e gratuita; questa nuova
realtà è sempre gestita dall'Accademia di San Luca e rappresenta
una scuola elementare al contrario della precedente Scuola del Nudo
.
Nel
1829 alcuni artisti attivi a Roma, fra i quali, Bertel “Alberto”
Thorvaldsen e Tommaso Minardi, dell'Accademia di San Luca, e Horace
Vernet fondano la Società Amatori e Cultori delle Belle Arti con lo
scopo di organizzare mostre e occuparsi delle vendite delle opere. Le
mostre si svolgevano nel Palazzo della Dogana Vecchia a Piazza del
Popolo e, dal 1884, nel Palazzo delle Esposizioni disegnato
dall'architetto Pio Piacentini e inaugurato nel 1883 .
Nel
1858 il marchese Francesco Patrizi fa costruire un edificio in via
Margutta e apre un centro per studi di artista, gli Studi Patrizi, in
cui nel 1887 prenderà sede l'Associazione Artistica Internazionale
dove, fra gli altri, Umberto Boccioni, ex-allievo di una delle scuole
per artieri del Comune di Roma, tiene una conferenza il 29 maggio
1911 come mostra anche la lapide commemorativa presente sul sito.
Tale
è l'ambiente educativo di Roma preunitaria, con scuole sia a
pagamento sia gratuite, e alcune serali dedicate ai giovani
lavoratori. Queste iniziative nutrono la nascita nel periodo
post-unitario di scuole variegate che riprendano gli insegnamenti del
disegno e dei mestieri artistici, assopiti negli ultimi decenni
post-repubblicani. La rivoluzione industriale nell'Ottocento
spalanca le porte all'istituzione delle scuole di arti e mestieri
per gli artieri che si specializzano nelle arti industriali. Le
richieste della nascente realtà industriale spingono queste scuole
verso il successo e trovano ampio spazio e credito nel Regno
d'Italia.
Nel
1871, all'indomani dell'Unità d'Italia, il sistema
d'istruzione pontificio è distrutto, l'edificio dell'Ospizio
Apostolico di San Michele è espropriato e affidato al Comune di
Roma, nasce quindi l'Istituto Romano San Michele. Le scuole d'arte
sono progressivamente chiuse, mentre la struttura carceraria è
unificata e destinata a riformatorio minorile che resta attivo fino
al 1972. Nel 1938 l'istituto assistenziale è trasferito a Tor
Marancia dove è depositata una parte delle opere d'arte originarie
delle scuole d'arte.
Attualmente l'edificio originale in via San Michele a Trastevere
ospita uffici del Ministero della Cultura.
Nel
1873, dopo l'Unità d'Italia e Roma Capitale, l'istituto
pontificio di San Luca prende il nome di Regia Accademia e la Scuola
di Belle Arti diviene Istituto di Belle Arti di San Luca secondo il
regio decreto 1634/1873, l'Istituto di Belle Arti con il regio
decreto 2007/1874 si separa dall'Accademia ed è, in seguito,
rinominato Accademia delle Belli Arti di Roma. Mentre la Regia
Accademia nel 1948 diventa l'attuale Accademia Nazionale di San
Luca .
Al
momento in cui Roma entra a far parte del Regno d'Italia e lo Stato
Pontificio si disgrega, il sistema scolastico prevede, come in
precedenza illustrato, scuole private regionarie e religiose di tutti
i livelli, a pagamento e gratuite. Nel 1870 si registra a Roma un
tasso di analfabetismo inferiore al 60% tra le più basse nel paese
unito. Gabelli nel 1881 precisa che nonostante la scuola non fosse
una novità a Roma, lo è la nuova organizzazione statale che
s'instaura progressivamente nei primi anni di Roma Capitale .
Le nuove scuole, divenute obbligatorie per applicazione della legge
Casati n. 3725 del 13 novembre 1859, sorgono su un terreno educativo
piuttosto consolidato in cui le famiglie mandano i figli a scuola, ma
sono sostanzialmente diverse dal passato con l'istituzione di
scuole statali, elementari e superiori, in prevalenza licei classici
e istituti tecnici. La predilezione per gli studi classici comporterà
controversie e discussioni per i decenni a seguire .
In contemporanea, l'istruzione professionale è lasciata in quegli
anni all'iniziativa dei comuni che, inizialmente, gestiscono anche
le scuole elementari, e che si vedono quindi invitati a contribuire
cospicuamente all'istruzione pubblica. Le scuole private, prima
sostenute dai comuni, soccombono sotto la vasta scelta di scuole
gratuite e nel 1870-71 il comune di Roma ha 735 scuole comunali che
crescono negli anni immediatamente seguenti fino a superare il
migliaio nel 1875-76 .
Nel 1871, il Comune di Roma gestisce le scuole elementari, le serali
maschili e le festive femminili, a queste si aggiunge la scuola
professionale che le leggi italiane - Casati e Legge Coppino n. 3961
15 luglio 1877 - trascurano e affidano ai comuni con la sovvenzione
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. A queste leggi
seguono le circolari ministeriali del 7 ottobre 1879 sulle scuole
d'arte e mestieri e d'arte applicata all'industria e del 24
gennaio 1880 riguardante l'apertura delle stesse scuole nelle fasce
serali e domenicali. Il Comune di Roma anticipa quanto chiesto nelle
citate circolari dedicando una congrua parte della spesa comunale per
l'istruzione professionale .
A Roma «la cultura degli artieri e quella della donna furono
soggetto di assidue e costose cure»
.
Roma
diventa Capitale d'Italia con la legge 33 del 3 febbraio 1871, a
seguito di ciò diversi edifici sono espropriati per far posto agli
uffici necessari al trasferimento della Capitale e l'insediamento
della pubblica amministrazione. Il percorso di alienazione dei beni
ecclesiastici prosegue e il 19 giugno 1873 il governo italiano
promulga la Legge 1402 che estende alla città di Roma il Regio
Decreto 3036 del 7 luglio 1866 e la legge 3848 del 15 agosto 1867
sugli espropri dell'Asse Ecclesiastico. La legge 1402 prevede
l'istituzione di una Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico
di Roma che prende possesso, fra gli altri, del convento di San
Lorenzo in Lucina, del Collegio Romano, di Santa Maria in Monticelli,
di Sant'Agata in Trastevere, di San Pantaleo, del convento di Gesù
e Maria al Corso, di Sant'Andrea delle Fratte, di San Giuseppe a
Capo le Case .
Queste leggi, dette eversive, includevano anche le scuole religiose
che sono in alcuni casi soppresse ed espropriate. Molti sono i
ricorsi presentati in tribunale e, in alcuni casi vinti.
Ciononostante, questi istituti passano sotto il controllo dei
ministeri pertinenti quali ad esempio il Ministero della pubblica
Istruzione nel caso delle scuole .
Il Collegio Romano è ceduto al Ministero della Pubblica Istruzione
che vi fonda il liceo e il ginnasio Ennio Quirino Visconti e il Regio
Istituto Tecnico .
I beni espropriati sono in parte ceduti al Comune di Roma, secondo
l'articolo 8, che li usa anche per collocarvi le scuole elementari
e professionali che sono, sulla base delle leggi in corso, di sua
pertinenza. L'articolo 2 della legge 1402 prescrive che i beni
religiosi espropriati che erano destinati a scuole mantengano la
destinazione d'uso originale .
Conseguentemente, gli edifici che giungono al municipio sono
utilizzati, negli anni seguenti, come scuole. Nella guida Monaci del
1871, troviamo, quindi, una trentina di scuole elementari situate in
ex-conventi ed ex-residenze di ordini religiosi, fra cui una anche a
Santa Maria in Monticelli, nel convento dei Dottrinari. Sono ceduti
al comune di Roma anche Sant'Agata, San Pantaleo, Santa Dorotea,
Gesù e Maria al Corso. San Lorenzo in Lucina è ceduto alla
Provincia di Roma.
Nel
1871, il comune di Roma istituisce la prima scuola per artieri e
negli anni a seguire sono fondate cinque scuole. Questi nuovi
istituti sono spesso collocati, come per le scuole elementari, nei
locali espropriati a ordini religiosi che, talvolta, ospitavano
originariamente già scuole di dottrina cristiana e di disegno nei
primi dell'Ottocento, come in precedenza esposto.
Le
scuole serali per artieri nascono e fioriscono poiché concepite per
venire incontro alle esigenze dei lavoratori;
esse
rispondono alle necessità che scaturiscono dalla contemporanea
rivoluzione industriale così come dall'affermarsi del movimento
Arts and Crafts di William Morris e John Ruskin. Questo movimento
rimandava a una valorizzazione dell'artigianato ed ebbe fulcro
geografico nel Regno Unito ma estensione in tutto il mondo negli anni
a seguire: la Red
House,
esempio più completo del pensiero di Morris (e Philip Webb), è del
1860 e sarà completata nel 1862. In questo clima di cambiamento
sociale e fermento artistico, nel 1852 nasce a Londra il South
Kensington Museum, ribattezzato Victoria and Albert Museum nel 1899.
Nei decenni successivi aprono in tutta Europa diversi musei e scuole
volte a costruire un dialogo tra arte e industria.
Il
1° dicembre 1871 il Municipio di Roma istituisce una scuola serale
maschile di Disegno per artieri, che hanno già frequentato la scuola
elementare, nel Rione Colonna nell'ex convento di Sant'Andrea
delle Fratte .
Nell'ottobre del 1871 la giunta approva l'istituzione di una
scuola per artieri diretta da Francesco Echert, ingegnere e «maggiore
d'artiglieria in ritiro del Reale Esercito»
,
con deputato soprintendente Cesare Mariani, pittore romano,
consigliere comunale, e in seguito commissario per il Museo Artistico
Industriale. Anche l'orefice Augusto Castellani ne sarà
sopraintendente e compare menzionato nella guida Monaci del 1879 .
La scuola inizia le lezioni nel novembre successivo, l'inizio è
graduale. Echert, nella relazione di fine anno, indica, infatti, il
gennaio 1872 come vera partenza della scuola e i mesi finali del 1871
come preparatori, anche per la penuria di suppellettili e materiale
essenziale per la didattica. Nell'anno scolastico 1871-72 la scuola
è frequentata regolarmente da 136 allievi ammessi all'anno
successivo; è quotidiana, serale (con orari variabili nell'anno
dalle 18-21 alle 20-22), le lezioni durano dalle due alle tre ore, il
sabato non ci sono lezioni, ci sono lezioni la domenica mattina e,
nei mesi di maggio e giugno anche lezioni di disegno diurne dalle 11
alle 15. Già nel primo anno d'istituzione arrivano alla scuola
donazioni da privati cittadini di gessi ed esemplari per le lezioni
di disegno. Fra questi, Echert ricorda esemplari in gesso d'ornato
del ‘500, dodici pezzi degli ornati di Urbino e trenta tavole del
De Vico. Il successo della prima scuola per artieri convince
l'amministrazione ad aprirne subito un'altra nell'anno
scolastico 1872-73, nel Rione Regola al Monte di Pietà. Le scuole in
quest'anno scolastico attirano 211 studenti frequentanti. Nel 1873
apre una succursale in via di Propaganda, nel 1875 la terza scuola
per artieri intitolata a Ettore Rolli è fondata in via del Boschetto
nel Rione Monti. Ettore Rolli botanico, professore universitario,
sopraintendente nelle scuole lascia una somma in denaro da destinare
a premi per gli studenti. Nel 1876 nelle tre scuole per artieri sono
attivi corsi per le arti fabbrili, meccaniche, murarie, decorative
(fra cui già compare la fotografia) oltre a tipografi, litografi e
sellai. In queste scuole si tenevano anche lezioni speciali di fisica
sperimentale e di meccanica, inizialmente solo nei giorni festivi,
nel 1881 diventano insegnamenti ordinari come gli altri a causa del
successo presso gli allievi. Il fine di queste scuole è di
specializzarsi nelle arti in cui i giovani discenti già operano
durante il giorno: lo scopo non è di avviare all'esercizio di una
professione, non ci sono quindi officine, ma s'insegnano discipline
che combinano i bisogni degli allievi e le nozioni necessarie al
perfezionamento dell'arte. Gli insegnamenti offerti sono quelli
generali quali l'aritmetica, il sistema metrico, la geometria
teorico-pratica, il disegno geometrico. Nell'anno successivo, gli
studi proseguono in disegno ornamentale, architettonico e
industriale. A supporto di queste istituzioni il Comune, anche grazie
alle sovvenzioni della Provincia, del Ministero d'Istruzione e del
Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, fonda tre scuole
preparatorie, collocate tra le scuole elementari e quelle degli
artieri, in cui si tengono anche i corsi del primo anno di
quest'ultime. Testimonianza della qualità dei corsi impartiti è
la partecipazione con tre album di opere eseguite da studenti per
complessivi trecento tavole e seicento disegni, raccolti sin dalla
fondazione, ciascuno riferito a un quinquennio, e che sono inviati
all'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884 .
La guida Monaci del 1874 indica tre sedi: la scuola n. 1, denominata
Centrale, a via dei due Macelli, presso il convento di Sant'Andrea
delle Fratte, la sua succursale a via di Propaganda 10, e la numero
2. a Piazza della Trinità dei Pellegrini .
Alle scuole per artieri propriamente dette, si aggiungono anche i
numerosi corsi preparatori per gli artieri che sono collocati nelle
scuole elementari comunali .
Le sedi delle scuole cambiano come muta l'urbanistica di Roma che
si adatta al nuovo ruolo e al nuovo stato. La scuola n. 1 cambierà
sede diverse volte in cerca di spazi adeguati fino a essere
statalizzata .
La scuola n. 2 negli anni Ottanta troverà spazio in una parte
dell'ex-convento dei Dottrinari di Santa Maria in Monticelli alla
Regola, in seguito all'esproprio operato dalla Giunta Liquidatrice
dell'Asse Ecclesiastico, in una sede che un tempo ospitava una
scuola pre-unitaria di disegno, precedentemente menzionata, in quella
che si chiamava Piazza S. Paolino alla Regola ora denominata Piazza
San Paolo della Regola .
La scuola n. 2 era denominata “Nicola Zabaglia” già a fine
Ottocento e si trova così indicata nella Guida Monaci del 1890.
I lavori di ristrutturazione non sono particolarmente invasivi poiché
l'edificio già ospitava una scuola e includono l'apertura di un
ingresso indipendente sulla piazza dalla trasformazione di una
finestra. L'edificio, infatti, è diviso in varie parti, una
sezione è in uso alla parrocchia di Santa Maria in Monticelli,
un'altra ospita la curia generalizia dei Padri Dottrinari. Negli
spazi dell'ex-convento, oltre la scuola, s'insedia anche una
caserma, in affitto fino al 1896. Nei locali del quarto piano, quando
anche questa parte è, infine, occupata dal Comune, si trova
l'archivio dei Beati di casa Savoia che ivi rimane in affitto. Nel
1937, i locali posti al piano terzo saranno retrocessi al Fondo del
Culto (allora Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma)
.
Nel 1961, i locali ai piani terra, primo e secondo sono attribuiti
alla scuola per artieri, con una scala che li collega dall'ingresso
nella piazza; al piano terzo c'è il Fondo del Culto. I rimanenti
due piani, quarto e quinto, sono concessi dal Comune, che ne conserva
la proprietà, ai Padri Dottrinari. L'accesso agli ultimi piani è
collocato in via Santa Maria in Monticelli 28 e persiste su di esso
una servitù attiva da parte del Comune .
Diverse succursali sono state istituite, nel tempo, per accogliere i
molti allievi che s'iscrivevano. Fra queste, una sede era in via
Galvani e, nel 1886, la via all'angolo dell'edificio fu
intitolata a Nicola Zabaglia .
Nel 1877 s'insegnano nelle tre scuole per artieri nella città di
Roma: «aritmetica e sistema metrico, geometria teorico-pratica con
applicazioni e disegno geometrico, elementi di architettura e disegno
architettonico, nozioni tecniche secondo le professioni e disegno
professionale»,
vi è un corso di prospettiva e di disegno ornamentale e lezioni
straordinarie di geografia e storia patria nonché igiene e doveri
del cittadino .
Nel 1875 la scuola n. 3 intitolata al medico botanico Ettore Rolli ha
sede nel Rione Monti a piazza Trinità dei Pellegrini; in seguito,
varie sedi si susseguono, fra cui via dei Giubbonari, via Urbana, via
Farini, per arrivare infine nell'attuale sede di via Macedonia 120
nel quartiere Appio Latino. Questa scuola aveva inizialmente una
vocazione verso la Chimica industriale, che, nel 1917, è trasferita
alla scuola n. 4 che apre in Viale Glorioso ed è, infatti,
denominata, inizialmente, “Scuola di Chimica Industriale”, in
seguito prenderà il nome “Scienza e Tecnica” .
Questa nuova istituzione era stata fondata «allo scopo di fornire
agli operai chimici ed ai proprietari di piccoli stabilimenti di
industrie chimiche, od aventi attinenza con la chimica: saponieri,
tintori, conciatori, elettrochimici, ceramisti, metallurgici,
coloristi, profumieri, fotografi, commessi di farmacia»
nozioni tecnico-pratiche atte a svolgere al meglio la professione. In
questa scuola si tenevano lezioni di Fisica e Chimica generale,
tenute da Rinaldo Guareschi, di Chimica tecnologica, tenute da
Riccardo Belasio .
Nel
1874 Baldassarre Odelscalchi, presidente dell'Associazione
Artistica Industriale, crea con l'orefice Augusto Castellani il
Museo Artistico Industriale MAI nell'ex-convento di San Lorenzo in
Lucina in Campo Marzio. L'iniziativa aveva ricevuto già nel 1872
il plauso e l'approvazione del Consiglio comunale ,
in seguito Odescalchi e Castellani, con Luigi Marchetti, Alessandro
Castellani, Antonio Cipolla, Giovanni Montiroli e Guglielmo de Santis
sono nominati nella commissione organizzatrice del nuovo museo .
Il
museo si proponeva come polo pedagogico per arrivare a crescere un
gusto artistico nella produzione degli oggetti prodotti
industrialmente. Conseguentemente, il museo era organizzato per
essere uno strumento didattico per lo studio delle forme e
dell'ornato al fine di formare gli artigiani impiegati in botteghe
e cantieri di Roma. L'istituzione del museo, infatti, ha portato
all'apertura di scuole d'arte diurne domenicali nel 1876 per gli
insegnamenti di smaltatura dei metalli, di modellazione della cera e
di decorazione pittorica. In seguito, queste scuole diventano
quotidiane e serali con l'aggiunta degli insegnamenti degli stili,
della plastica decorativa, plastica in cera per le industrie,
rialzatura a ribalzo, di cesello, di niello e di smalto .
Nel 1880, aprono i corsi serali organizzati su base triennale con
insegnamenti quali pittura, disegno, modellazione della creta, marmo,
legno, stucco e vi si tengono conferenze di storia dell'arte
(sostenute dal Ministero della Pubblica Istruzione) e concorsi di
composizione; le scuole sono denominate nel 1885 “Scuole di arte
applicata all'industria di Roma”, e sono sovvenzionate dal Comune
e dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio .
La proprietà degli oggetti conservati nel museo sono formalmente
accettati dal Comune di Roma nella delibera di Giunta n. 13 del 1
ottobre 1884; negli atti del consiglio comunale del 27 ottobre è
riportato l'elenco da cui si evincono, fra gli altri, donazioni
da parte del pittore Cesare Mariani, dei principi Odescalchi, Baldassare e Ladislao, del barone Adolfo Rothschild, della Compagnia dei Vetri di Murano a Venezia, di Augusto e Alessandro Castellani, del conte Francesco Cini, di Antonio Cipolla, di Guglielmo De Sanctis, del marchese Ginori-Lisci, di Michelangelo Guggenheim, del museo Kircheriano, del principe Marcantonio Colonna, ecc. Gli oggetti includono, ad esempio, fotografie, libri, piatti, vasi, mattonelle, bicchieri e riproduzioni in gesso.
.
Le opere degli allievi sono presentate all'Esposizione
internazionale di Parigi nel 1878, all'Esposizione didattica
nazionale di Roma del 1880, a quella industriale di Milano del 1881 e
a quella Nazionale di Torino nel 1884. In quest'ultima sono
presentati un cospicuo numero di studi di gesso e invenzioni che ne
riprendono gli stili, elencati nella Relazione Sommaria del Comune di
Roma .
Il MAI ebbe, in successione, varie sedi. Nel tentativo di trovare
locali adatti, da San Lorenzo in Lucina fu trasferito al Collegio
Romano e, in seguito, a San Giuseppe a Capo le Case fino ad arrivare
a una sede definitiva nel 1927 in via Conte Verde. L'ente fu
soppresso nel 1954 e le collezioni disperse verso altri musei romani,
le scuole assimilate a Istituti d'arte .
Queste
iniziative artistico-pedagogiche si sviluppano in analogia ad altre
istituzioni fondate in quegli stessi anni, le scuole superiori di
Arti Applicate a Venezia nel 1873 e a Vienna, a Firenze in Santa
Croce nel 1880 e a Milano nel Castello Sforzesco nel 1882 .
Le
scuole di arte applicata accolgono inizialmente gli studenti
provenienti dalle scuole per artieri e dagli istituti tecnici. I
responsabili del comune di Roma – fra cui artisti, virtuosi del
Pantheon e accademici di San Luca che sopraintendevano le scuole per
artieri e che avevano fondato il MAI – notano vari livelli tra gli
allievi delle scuole artieri, quelli con livello d'ingresso più
elevato sono indirizzati verso un'altra scuola detta
“preparatoria”. Negli atti del consiglio comunale di Roma, in
occasione della votazione sui fondi destinati al MAI, s'introduce
tale necessità .
La “Scuola Preparatoria al Museo Artistico Industriale” è
fondata nel 1885 e prenderà in seguito l'attuale denominazione di
Scuola di Arti Ornamentali. Tra i fondatori della scuola troviamo
Luigi Bazzani, Cesare Biseo, Domenico Bruschi, Giuseppe Cellini,
Guglielmo De Santis, Cesare Mariani, Attilio Simonetti, Ludovico
Seitz, Ettore Ferrari, Giovanni Montiroli ;
alcuni tra questi, insieme ai sopraintendenti delle scuole per
artieri e ai fondatori del MAI, faranno parte della commissione
direttiva delle scuole comunali di disegno che dirige la didattica
della scuola preparatoria alle Arti Ornamentali
e nella guida Monaci del 1918 compare in commissione anche Duilio
Cambellotti .
La
fondazione del MAI è un'iniziativa che si allinea a ciò che
avveniva,
in quel periodo, in tutta Europa per altre scuole preparatorie come
quelle sorte in Francia come conseguenza dell'Esposizione
Universale del 1851, in seguito, a Napoli nel 1878 per i Musei di
Arte Industriale, il Werkbund di Monaco, il British Institute of
Industrial Art, il Bauhaus di Weimar all'inizio del ‘900 .
Questa nuova scuola si proponeva di estendere l'istruzione delle
scuole per artieri verso l'arte decorativa nel contesto industriale
che si studiava nelle Scuole del MAI .
In questo modo, il percorso didattico iniziava nelle scuole per gli
artieri, proseguiva nella scuola di arti ornamentali e, quindi,
trovava la sua naturale prosecuzione nelle scuole del MAI .
La
scuola romana di Arti Ornamentali era collocata originariamente in
via San Sebastianello 16 vicino a Piazza di Spagna nei pressi del
MAI. Nel 1887 la sede della scuola fu trasferita nell'attuale sede
a via di San Giacomo (già via degli Incurabili). La nuova sede sorge
in un'area che era di proprietà dell'ordine religioso degli
Agostiniani Scalzi dal 1615. In precedenza, era stata di proprietà
del Cardinale Flavio Orsini; successivamente all'acquisto l'ordine
religioso aveva convertito la villa cinquecentesca del cardinale in
convento. Sul sito sorgeranno la Chiesa di Gesù e Maria, diverse
botteghe, un oratorio, un'infermeria, nelle via Gesù e Maria, del
Corso e del Babbuino, infine un giardino confinava con via degli
incurabili. La comunità religiosa fu soppressa nel 1873. L'area
del giardino fu affittata al sig. Spinetta il quale, in seguito,
l'acquistò e chiese licenza di costruzione ottenendola nel 1872 .
Le
scuole arti e mestieri, le tre per artieri e quella di Arti
Ornamentali, mantengono un'organizzazione della didattica simile
sin dalla fondazione: sono serali, con orari inizialmente dalle 19
alle 22 poi posticipato alle 20, sono frequentate da giovani artieri
che lavoravano durante il giorno, sono previste anche attività di
domenica. La didattica è gratificata da premi che consistono in
libretti di risparmio, strumenti e libri .
La
scuola si distinse nel tempo crescendo in stima e ottenendo notevoli
successi e premi, fra cui la medaglia d'oro conferita dal Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio [conservata
in corridoio].
Nel tempo la scuola riceve diverse sovvenzioni comunali per
l'acquisto di opere d'arte e donazioni da privati come opere in
gesso, in ferro, marmi e libri che costituiscono una cospicua
collezione di oggetti dedicati alla didattica, e fra queste citiamo
le grottesche di Palazzo Altoviti .
Diversi artisti di grande livello sono passati per le scuole per
artieri di Roma, fra questi ricordiamo i futuristi Gino Severini e
Umberto Boccioni, anche attivo nella limitrofa Associazione Artistica
Internazionale, i membri della scuola romana Mario Mafai e Gino
Bonichi detto Scipione e Alberto Ziveri .
L'istituzione
del nuovo settore d'istruzione statale professionale della riforma
Gentile nel 1923 lascia le quattro scuole per artieri al tempo
esistenti alle dipendenze del Comune e fuori dal Ministero della
Pubblica Istruzione, così parimenti i successivi interventi
legislativi .
Le scuole per artieri del Comune di Roma sono quindi giunte ai nostri
giorni con la nuova denominazione “Arte e Mestieri”; sono
quattro, “Nicola Zabaglia”, “Ettore Rolli”, “Arti
Ornamentali” e “Scienza e Tecnica” e hanno adeguato gli
insegnamenti e gli indirizzi nel tempo, seguendo le riforme della
pubblica istruzione e senza sovrapporsi agli insegnamenti statali,
quindi, infine giungendo alla formazione permanente professionale per
adulti attuale.
(di
Simona Irrera)
BIBLIOGRAFIA
Atti
1872
Atti
del consiglio comunale di Roma,
1872, sedute del 28 ottobre e 4 novembre, proposta 43, archivio
storico capitolino, segretariato generale.
Atti
1883
Atti
del consiglio comunale di Roma,
1883, seduta del 14 dicembre, archivio storico capitolino,
segretariato generale.
Atti
1884
Atti
del consiglio comunale di Roma,
1884, seduta del 27 ottobre, proposta 57, archivio storico
capitolino, segretariato generale.
Atti
1886
Atti
del consiglio comunale di Roma,
1886, seduta del 25 maggio, proposta 118, archivio storico
capitolino, segretariato generale.
BENINCASA
2003
Giovanna
BENINCASA,
L'edificio
delle “Arti Ornamentali”,
in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia”, a cura di
Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.
CASSESE
2016
Giovanna
CASSESE (a cura di) Accademie / Patrimoni di Belle
Arti, Italia, Editore Gangemi, 2016.
CASTRACANE
2016
Marco
CASTRACANE,
Storia
delle Scuole d'Arte e dei Mestieri a Roma,
Roma, Editore Armando, 2016.
CIMBOLLI
Spagnesi
Piero
CIMBOLLI
SPAGNESI,
Dal
Regio Istituto di Belle Arti alla Scuola superiore di Architettura di
Roma. Ordinamenti e programmi delle origini,
1873-1915, in “BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA
DELL'ARCHITETTURA- L'Associazione Artistica fra i Cultori di
Architettura in Roma”, 1890-1930 a cura di Marina Docci e Maria
Grazia Turco, Editore Quasar, Roma, 2021.
COLLERILE
2003
Lucia
COLLERILE,
Allievi
ed Insegnanti: gli Artisti alla Scuola Arti Ornamentali dalla fine
dell'800 alla “Scuola Romana”,
in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di
Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.
CUTRì
2004
Maria
Teresa CUTRÌ,
scheda Dipartimento di Architettura e Progetto, Osservatorio sul
moderno a Roma, Ricerca “Scuole” per la Conservatoria del Comune
di Roma, 2004, Università “La Sapienza”,
https://web.uniroma1.it/archiscuole/sites/default/files/cutri61.pdf
Diario di Roma 1823
Diario di Roma del 5 novembre 1823, numero 88, Cracas, p. 2.
Diario di Roma 1847
Diario di Roma del 27 luglio 1847 numero 60, Cracas.
Giornale di Roma 1853
Giornale di Roma del 2 giugno 1853, n. 123, Tipografia Salviucci, p. 492.
ECHERT
Francesco
ECHERT,
SPQR Scuola
per Artieri, Relazione del primo anno scolastico 1871-1872 con
documenti,
manoscritto compilato dal Direttore della Scuola, Francesco Echert,
1872, Archivio Storico Capitolino.
FRANCESCANGELI
1871-1920
Laura
FRANCESCANGELI,
Politiche
culturali e conservazione del patrimonio storico-artistico a Roma
dopo l'Unità – il titolo 12
“Monumenti, Scavi, Antichità, Musei” 1871-1920 Viella Carte
Scoperte, Collana dell'Archivio Storico Capitolino.
GERMANO'
Donatella
GERMANÒ,
Museo
artistico Industriale,
in Roma dalla A alla Z, Simart Web, Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali,
https://simartweb.comune.roma.it/articolo/65.
D'ANDREA
1985
Gianni
D'ANDREA,
Gli
esordi della scuola Arti Ornamentali,
in “1885-1985 I cento anni della Scuola Arti Ornamentali” a cura
del Comune di Roma Assessorato all'educazione permanente.
D'ANDREA
2003
Gianni
D'ANDREA,
La
scuola “Arti Ornamentali”,
in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di
Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.
GABELLI
1881
Aristide
GABELLI,
Istruzione
primaria e secondaria nella città e provincia di Roma,
in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”
volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana 1881.
GUIDA
MONACI
1871
Tito
MONACI (a cura di), Guida
commerciale, scientifica ed artistica della capitale d'Italia, in
“Guida Monaci”
Roma,
Editore Tipografia Sinimberghi, 1871.
GUIDA
MONACI
1874
Tito
MONACI (a cura di), Guida
commerciale, scientifica, artistica ed industriale di Roma, in
“Guida Monaci”
Roma,
Editore Tipografia Bencini, 1874.
GUIDA
MONACI
1877
Tito
MONACI (a cura di), Guida
commerciale, scientifica, artistica, industriale, monumentale,
geografica, statistica, amministrativa e religiosa di Roma, in
“Guida Monaci”
Roma
1877.
GUIDA
MONACI
1879
Tito
MONACI (a cura di), Guida
commerciale di Roma, in
“Guida Monaci”
Roma
1879.
GUIDA
MONACI
1884
Guida
MONACI, Guida
commerciale di Roma, in
“Guida Monaci”
Roma
1884.
GUIDA
MONACI
1890
Guida
MONACI, Guida
commerciale di Roma e Provincia, in
“Guida Monaci”
Roma
1890.
GUIDA
MONACI
1918
Guida
MONACI in “Guida Monaci”
Roma
1918.
GUIDA
MONACI
1924-25
Guida
MONACI, Guida
commerciale di Roma e provincia, in
“Guida Monaci”
Roma
1924-25.
MASOTTI
1873
C.
MASOTTI
Notizie
sull'applicazione alla città di Roma ed alle sedi suburbicarie
della
legge 19 giugno 1873 n. 1402
in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”
volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana, 1881.
Maestri
del legno
2010
Mestieri
e botteghe nel cuore di Roma,
“Maestri del legno” Lignarius, Roma, Editore Spedalgraf 2010.
MORONI
1840
Gaetano
MORONI,
Dizionario
di erudizione storico-ecclesiastica,
Editore Battaggia, 1840.
PELLICCIA
1988
Guerino
PELLICCIA, Giancarlo ROCCA (a cura di), Dizionario
degli istituti di perfezione 1975-1988,
Roma, Edizioni Paoline.
PEVSNER
1982
Nikolaus
PEVSNER,
Le
accademie d'arte,
Torino, Editore Einaudi, 1982.
QUERINI
1881
Querino
QUERINI,
Della
Beneficenza Romana,
in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”
Volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana 1881.
Relazione
sommaria
1884
Relazione
sommaria sull'ordinamento delle scuole del Comune di Roma per
l'Esposizione Nazionale di Torino del 1884,
Editore Tipografia Fratelli Bencini, Roma, 1884.
RIDOLFI
1985
Fausto
RIDOLFI,
Note
di colore degli allievi illustri,
in “1885-1985 I cento anni della Scuola Arti Ornamentali” a cura
del Comune di Roma Assessorato all'educazione permanente.
ROCCASECCA
2019
Pietro
ROCCASECCA,
L'insegnamento
superiore nell'arte a Roma 1593-1940: dall'Accademia del Disegno
all'Accademia di Belle Arti in
“Accademia
di Belle Arti di Roma. Centoquaranta anni di istruzione superiore
dell'arte a Roma”,
2019.
SACCHI
LADISPOTO
2003
Teresa
SACCHI
LADISPOTO,
I
Padri Fondatori,
in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di
Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.
SANI
2008
Roberto
SANI,
Le
scuole notturne per gli artigiani nella Roma Pontificia (1818-1870),
in “Virtute et Labore studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi
settant'anni”, tomo secondo, a cura di Rosa Marisa Borraccini e
Giammario Borri, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo,
Spoleto 2008.
TRIGGS
1902
Oscar
Lovell TRIGGS,
Chapters
in the History of the Arts and Crafts Movement,
Bohemia Guild of the Industrial Art League, 1902.
VENUTI 1767
Ridolfino Venuti, Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna, Vol. I, Parte II, Roma, Carlo Barbiellini al Corso, 1767.
VILLOSLADA
1954
Ricardo
García VILLOSLADA,
Storia
del Collegio romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della
Compagnia di Gesù (1773),
Editore Apud aedes Universitatis Gregorianae, Roma, 1954.
VIOLA
2014
Valeria
VIOLA,
Dalle
scuole di disegno ai musei di arte industriale. Percorsi di
educazione ed istruzione artistico e professionale in Italia durante
l'Ottocento. L'esperienza del Molise,
Tesi
di Dottorato ciclo XXVI Università degli Studi di Macerata, 2014.
SITOGRAFIA
IRSM
https://www.irsm.it/storia-dellistituto-san-michele/,
recuperato in data 9 luglio 2025.
STRINATI
Tommaso
Strinati 6 aprile 2021 Il giornale dell'Arte –
https://dgabap.cultura.gov.it/complesso-monumentale-di-san-michele-a-ripa-grande,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
VIRTUOSI
https://www.accademiavirtuosi.it/,
recuperato in data 9 luglio 2025.
AAI
https://associazioneartisticainternazionale.wordpress.com/,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
V&A
https://www.vam.ac.uk/articles/building-the-museum#slideshow=31131014&slide=0,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
Vigna
Pia
https://www.vignapia.com/progetto-educativo/,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
SACBA
https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=61749,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
Arti
e mestieri
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF60668,
recuperato
in data 9 luglio 2025.
3)
1887 – LE RAFFAELLESCHE
DEL COMUNE DI ROMA E L'ESPROPRIO DI PALAZZO ALTOVITI DI PONTE
(di
Cristina Mochi)
La
Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma è oggi affidataria
delle vele provenienti dal demolito Palazzo Altoviti. Sebbene le
trattative siano iniziate molto tempo prima (diversi furono i
solleciti agli Altoviti per il restauro dello stabile), lo Stato
stabilisce l'esproprio del Palazzo Altoviti il 21 marzo del 1885 e
la consecutiva demolizione dello stabile per la risistemazione della
sponda sinistra del Tevere dal Ponte Elio al vicolo dello struzzo
(notificaz. Municipale 28 luglio 1886 n. 51403). Il Palazzo ‹‹posto
in Roma in Piazza di Ponte Sant'Angelo ai numeri Civici 32 al 35 e
via Paola n. 34 di proprietà di Altoviti Avila Corbizzo fu Giuseppe
e Altoviti Avila Vittoria fu Francesco in Toscanelli››
è espropriato per la cifra di 450.000.000 (17 aprile 1887), eccetto
alcuni oggetti familiari, tra cui lo stemma sull'angolo, il busto
di Cellini e alcuni quadri. Preventivamente, Emilio Pavillion della
Direzione Tevere aveva provveduto al sopralluogo dal quale era emerso
che al piano nobile del palazzo erano conservate due
stanze
dipinte con affreschi a ornamenti di notevole interesse. Nei locali
vi erano anche i busti, antichi e moderni, tra cui si evidenziava
quello eseguito da Benvenuto Cellini rappresentante Bindo Altoviti.
Nel marzo del 1885, il direttore delle Antichità e Belle Arti,
Giuseppe Fiorelli, dirige i lavori atti alla rimozione dei dipinti da
preservare dalle demolizioni, indicando per la valutazione una
commissione composta da Filippo Prosperi, direttore delle Belle Arti,
Cesare Maccari e Guglielmo de Sanctis, tutti parte della commissione
che, dopo un'attenta analisi, stabilisce la necessità di salvare
parte della decorazione presente nelle due sale al piano terreno, in
cui figurano ‹‹volte
lunettate con pitture ad affresco attribuite a Vasari e ai fratelli
Zuccari e nel fondo delle nicchie busti antichi e moderni››.
Finalmente
nel 1886
il
Ministero dei Lavori Pubblici e quello delle Belle Arti stabiliscono
in accordo che alcuni affreschi del Palazzo Altoviti dovranno essere
salvati e quindi dovranno esser rimossi. Il rendiconto
richiesto dai proprietari all'architetto Azzurri ci dà
un'interessante descrizione dello stato del palazzo che non sembra
versare in cattive condizioni di conservazione. La facciata sul
Tevere mostra l'elegante loggia
che viene riconosciuta come la Banca Altoviti. Al piano nobile
figurano 26 camere, tre delle quali sopra la banca del proprietario.
Molti ambienti si trovano in povere condizioni. Anche Pavillion nel
suo reportage
aveva dichiarato che la loggetta sembra non essere stata completata e
che durante l'inondazione del 1870 il piano nobile era
stato danneggiato. L'ingegnere capo del Corpo Reale del Genio
Civile Cerutti richiede le chiavi del Palazzo ai proprietari (31
maggio 1887). Il termine del possesso Altoviti è stabilito al 10
giugno 1887. Dal ‹‹collaudo
del distaccamento››
del 21 gennaio 1888 si evince che il restauratore Pietro Cecconi
Principi, affidatario dei lavori, aveva già proceduto al distacco di
23 affreschi della volta della prima sala (riportati su tela)
‹‹meno
i 4 tondi in stucco››,
perché nel tentativo di rimuoverne uno, essendo lo stesso ancorato
con grappe metalliche, era andato distrutto. Gli affreschi devono
essere trasportati alla Accademia di Scienze di Palazzo Corsini .
Nel febbraio del 1888 il rapporto dei lavori riporta che sono già
stati asportati gli affreschi del 1500, i tre stucchi rimasti saranno
distaccati (con
incassatura)
quando la demolizione arriverà al soffitto della stanza, e i dipinti
presi (staccati senza
permesso
da Pietro Cecconi Principi) devono essere depositati presso il Reale
Istituto per valutare se potranno essere rilasciati al restauratore o
meno. Nella stessa relazione si dichiara che le altre opere rimaste
saranno lasciate in
situ,
perché il Ministero non prevede bilanci per pitture del periodo
della “decadenza” .
La postilla allo scritto dichiara però un intento importante: i
giovani dell'accademia e delle scuole d'arte potranno copiare
soffitti e altro, per il loro studio o affinché ne rimanga memoria.
Alla fine di febbraio, il Ministero chiede a Cecconi Principi la
riconsegna delle chiavi perché ‹‹la
parte principale e più importante della sala maggiore››
era stata rimossa .
Nella sala minore rimangono invece ancora gli stucchi sopracitati.
Gli affreschi vennero portati a Palazzo Corsini (26 marzo 1888) e
furono lasciati alla demolizione ‹‹le
decorazioni o raffaellesche della loggetta››
per gravi condizioni di deterioramento (27 aprile 1888). La
demolizione del Palazzo Altoviti nel 1888 sembrerebbe concludere la
storia degli affreschi, ma in realtà i documenti aprono a nuovi
aspetti in cui si inserisce l'intenzione illuminata di Cecconi
Principe prima e del Comune di Roma poi.
Il
Ministero di Belle Arti e Pubblica Istruzione, alla proposta di
acquisto per la Scuola di Ornato dell'Istituto, declina l'offerta
ritenendo i pezzi in pittura e in stucco di Palazzo Altoviti staccati
arbitrariamente
dal Cecconi Principe ‹‹segno
di epoca di decadenza, mentre nelle intenzioni delle accademie gli
allievi devono essere educati al meglio››.
Il 15 ottobre 1888 il Direttore Generale Fiorini chiede al Presidente
dell'Accademia dei Lincei di ‹‹voler
ricevere in deposito altri pezzi in istucco e ad affresco staccati
dalle volte di Palazzo Altoviti […] e a voler rilasciare ricevuta
come per quelli per cui venne fatta consegna a marzo››.
Risulta chiaro da quanto menzionato che, al primo distacco,
consegnato a marzo, ne seguì un secondo, quello non autorizzato ma
sempre eseguito da Cecconi Principe, come da lettera dello stesso
datata al 18 agosto 1888; la ‹‹consegna
all'Istituto di Belle Arti delle pitture distaccate senza
licenza
nel palazzo Altoviti››
prevede: ‹‹4
quadri con figure, ornati e putti con cornici in stucco, 4 quadri con
figure e cornici in stucco, 3 quadri con lotte di centauri, 2 quadri
con Flore, 5 quadri con giochi di putti, 1 mascherone, 2 quadri con
mezze lunette con cornici in stucco››
.
Cecconi Principi nella stessa occasione consegna anche i tre stucchi
staccati dalla sala minore. Il Ministero purtroppo non può
provvedere a tali frammenti, ma già nel giugno dello stesso anno il
Comune di Roma in una lettera al Prof. Boselli della Pubblica
Istruzione fa sapere che è ‹‹disposto
a proprie spese a riconnettere tutti i pezzi in un edificio prossimo
al Palazzo Altoviti››,
nell'intenzione di ricomporre l'antica loggia Altoviti! Il 18
aprile del 1890, come risulta nel carteggio della Commissione
Archeologica
dell'Archivio Capitolino, nella nota di pitture si fa riferimento
ai 3
archi con velette
(2 pezzi ognuno), alle 3
lunette con velette
(2 pezzi ognuno) e ai 23
frammenti con figurine e ippogrifi,
pezzi di cui sarà tutore Cecconi Principe presso il magazzino di via
degli Incurabili a Roma, oggi via di San Giacomo. Nel
1921, difatti, la strada cambiò il nome e da Via
degli Incurabili
divenne Via
di San Giacomo.
La storia toponomastica di questa via è, e rimane, legata
all'Ospedale di San Giacomo, detto un tempo degli
Incurabili,
e alla Chiesa di San Giacomo in Augusta. Sulla strada si affacciava
il Convento degli Agostiniani Scalzi, sostituito dopo l'annessione di
Roma al Regno d'Italia da un palazzo per uffici dove poi si è
insediata la Scuola di Arti Ornamentali del Comune. Dal
carteggio emerge anche che al 21 aprile dello stesso anno (1890) i
materiali sono esposti a Palazzo delle Esposizioni. Si specifica che
i frammenti erano stati trasportati su tela da Pietro Cecconi
Principe per la demolizione del Palazzo Altoviti. Gli affreschi sono
‹‹opera
del 1500 di ignoto››.
1500
- “Libertà
vo' cercando ch'è sì cara”. Gli anni di Bindo Altoviti e i
fuorusciti fiorentini
‹‹Ricordo
come a dì 3 di luglio 1553 si fecie al medesimo Messer Bindo
Altoviti una loggia in fresco con le guide di stucco con assai storie
e di Cerere e di tutti e mesi dell'anno che fu gran lavoro e portò
detta loggia scudi cento cinquanta, che parte andò a conto delle
spese che ebbimo tutto il tempo che fini fino a quello a tutto
dicembre 1554, scudi 150 ››”.
Così riferisce Giorgio Vasari nelle sue “Vite”
in merito all'opera che lo trattenne suo malgrado a Roma prima del
ritorno a Firenze. I rapporti tra l'artista e la famiglia
fiorentina Altoviti sono documentati dalle numerose commissioni
databili fin dagli anni Quaranta, come quella per la ‹‹grandissima
tela in San Giovanni››”
(1542) e prima ancora la Pala
d'altare
dell'Immacolata
Concezione
per la cappella di famiglia ai SS. Apostoli sempre a Firenze (1541),
il Cristo
portacroce
(1553), più tardo, e la Pietà,
ora in collezione privata. A Roma, Bindo Altoviti (1491-1556), di
famiglia fiorentina, nel 1513 aveva restaurato il palazzo paterno,
sito nel rione Ponte, quartiere dei banchieri sulle sponde del
Tevere, fronteggiante Castel Sant'Angelo. Ne risultò così una
grande residenza grazie anche all'annessione di alcune case vicine.
Dalla demolizione di alcuni caseggiati sul lato di sinistra ne era
derivata una grande piazza, appunto degli Altoviti, gremita di
botteghe affittate ad artigiani. Sull'altro fianco, verso via
Giulia e la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, era il portone
d'ingresso all'edificio, che apriva verso un piccolo cortile, da
cui una scala portava allo studiolo e alla loggia. «Da questo
Antonio (di Bindo Altoviti) e Dianora (Cibo) nacque Bindo, il
quale continuò a stantiare in Roma, et à pena fatto maggiore
acquistò la piazza detta anche hoggi degl' Altoviti (di
Ponte), quale per render maggiormente spatiosa gli fu di mestiere
fare il gettito di alcune case, che erano ad essa d'impedimento...
ristaurò la casa comprata dal padre in quella guisa che hoggi si
trova, e di ciò ne fa testimonianza l'inscrittione
in un marmo posta nel cortile della sudetta casa, et è del seguente
tenore: i* Bindus Antonii de Altovitis nobilis Florentinus domum ab
ejus genitore emptam restauravit anno MDXIIII. Altre case furono
gettate a terra per fare un po' di piazza, perciò detta Altovita››
.
Oltre alle due dimore sopracitate, un terzo palazzo venne acquisito
da Bindo Altoviti, del quale ce ne dà riscontro Rodolfo Lanciani:
«Vi è memoria di una terza casa con giardino e loggia sul Tevere
comperata da Giovanbattista Perini da Firenze. (Ivi, c.
159). In questo Palazzo Altoviti furono radunati più tardi
tesori d'arte grandissimi, incominciando dal busto di Bindo,
modellato da Benvenuto Cellini, che il Camerlengato Pontificio aveva
fatto incatenare alla parete del salone, e che oggi è migrato ad
altri climi››
.
La loggia descritta nel Protocollo notarile deve essere riconosciuta
come quella prospiciente
il Tevere ancora visibile nelle fotografie ottocentesche prima delle
demolizioni. Tale loggia, infatti, viene descritta come loggia
delle statue
per la collezione antiquaria esposta in essa e già documentata da
Ulisse Aldrovandi intorno al
1550
.
Qui doveva essere stato sistemato il celebre busto in bronzo opera di
Benvenuto
Cellini
,
forse commissionato in
occasione della nomina di Bindo Altoviti a senatore fiorentino nel
1546. Nel 1550 Michelangelo ne rimase impressionato tanto da
definirlo «superiore
agli antichi››.
La sala grande o della loggia era stata decorata da Giorgio Vasari,
ospite di Bindo. Vasari
aveva soggiornato presso gli Altoviti nel novembre del 1551,
nell'estate e nell'autunno del 1552 e poi dalla Pasqua del 1553
fino a dicembre dello stesso anno. L'artista aveva concluso la
volta col Trionfo
di Cerere nel
palazzo di Bindo Altoviti nel 1554, opera dal 1939 ricomposta a
Palazzo Venezia. Durante l'ultimo soggiorno presso gli Altoviti a
Roma, Vasari si occupa degli affreschi del Palazzo di Ponte e,
secondo l'Alveri, della decorazione di una seconda loggia,
appartenente alla Villa ai Prati di Castello, acquisita
successivamente dal figlio di Bindo, Giovan Battista. Difatti Giovan
Battista, figlio di Bindo e di Fiammetta de' Soderini, «ornò
parimente la vigna paterna, che è la medesima posseduta hoggi
dagl'Altoviti situata incontro all'Orso a Ripetta dall'altra
parte del Tevere ,
hauendo la sua entrata fuori di porta di castello, quale ornò di
bellissime statue uendute poi alli duchi di Savoia, e già ritrouate
nella villa Adriana che era come anche hoggi è degli Altoviti,
qual vigna è molto celebre per una gran loggia, ivi dipinta da
Giorgio Vasari con molta vaghezza, che in questo genere tiene il
secondo luogo doppo la famosa de' Chigi alla Lungara››
.
Proprio nella vigna, ossia nella villa suburbana, Vasari dipinse una
magnifica loggia «piena di Storie e figure in fresco grande con uno
ornamento di stuco tutto con mio disegnio››.
La "vigna" andò distrutta durante l'assedio di Roma nel
1849, ma le decorazioni erano già scomparse da tempo come si evince
dalla recente pubblicazione di Alice Silvia Legè .
Le
informazioni tratte da Le
Vite
e dalle Ricordanze
di Giorgio Vasari e dai documenti d'archivio confermano la presenza
di due dimore Altoviti: quella di città, il Palazzo di Ponte o di
Banchi, e quella di campagna, la Vigna dei Prati di Castello oltre il
Tevere in prossimità di Castel Sant'Angelo. Se poco si può
aggiungere in merito alla loggia della Vigna perché distrutta, più
complesso appare il discorso legato alla loggia del Palazzo di Ponte,
soprattutto grazie alla revisione dei documenti relativi alla
demolizione del complesso. Difatti, come visto, nel 1887, un anno
prima che il palazzo venisse abbattuto per la Legge
del Tevere
e la consecutiva realizzazione degli argini, gli affreschi vasariani
vennero separati dal muro con una tecnica affine a quella detta dello
"strappo" dal pittore-restauratore Pietro Cecconi Principi,
montati su tele (un grande ovale centrale e complessivamente oltre 40
frammenti-in due tempi) e, insieme agli scudi in stucco, vennero
trasportati in Palazzo Corsini alla Lungara, sede oggi della Galleria
Nazionale d'Arte Antica. La volta Altoviti venne ricomposta dal
pittore Torello Rupelli, che si occupò anche dell'integrazione degli
affreschi e della loro contestualizzazione all'interno della sala,
ottenuta con paraste di gusto rinascimentale decorate a grottesche
che corrono verticali lungo le pareti (1932). Rupelli non
ricostruisce le arcate mancanti della loggia aperta verso il Tevere,
ma alterna vele di diversa grandezza sui lati lunghi in perfetta
simmetria. Grazie
al nuovo restauro del 2003 sono state individuate le parti originali
e quelle integrate nel ‘900 da Rupelli e chiarite le questioni
tecniche relative al trasporto e all'ancoraggio degli affreschi alle
strutture preesistenti della sala. È stata inoltre ritrovata una
botola, corrispondente al monocromo raffigurante Cerere
che affida a Trittolemo la sua missione
- le cui cerniere dopo la pulitura appaiono evidenti - che ha
permesso di rivedere la soprastante volta della Sala Pisana. Torello
Rupelli restaura i frammenti originali, spesso ridipingendoli, e li
inserisce all'interno di nuove composizioni decorative prodotte ex
novo, previste per il riadattamento obbligato dalle nuove proporzioni
della sala di Palazzo Venezia. Alcune fotografie dell'epoca
dimostrano la distanza tra gli ornati cinquecenteschi e quelli oggi
risistemati nel museo.
Giorgio
Vasari, per
il Palazzo di Ponte, infatti, nel
novembre del 1553 affrescò, in sole tre settimane, la loggia del
palazzo di Bindo Altoviti, mecenate e banchiere di origine fiorentina
al servizio del pontefice Giulio III Ciocchi Del Monte (1550-55); nel
1551 Vasari era anche intervenuto sulla facciata del palazzo
realizzando lo stemma di Giulio III.
Sotto
il segno del lupo. Giochi eruditi e fantasie romane
Non
v'è dubbio sulla mano che ha eseguito il partito centrale della
sala della loggia: Giorgio Vasari ne parla nelle sue Rimembranze
e la realizzazione dell'Omaggio
a Cerere
è certamente da attribuirsi a lui. Da parte sua nelle fonti non è
documentato nessun intervento nella sala più piccola, non perché
Vasari la consideri un tutt'uno con la sala della loggia
, ma semplicemente perché, a parer mio, non vi ha operato. La sala
minore aveva un partito decorativo che includeva i 4 stucchi tondi,
tre dei quali rimossi, a fine demolizione, da Cecconi Principi (ora
in Palazzo Venezia). Vero è anche che lo stesso Vasari indica nella
lettera al cardinale Sforza Almeni
come presenti all'impresa i suoi collaboratori, Marco da Faenza e
lo stuccatore Matteo di Nicolò veneziano. Gli stessi sopracitati
avrebbero poi lavorato spalla a spalla con il Vasari a Palazzo
Vecchio a Firenze, in cui vi sono decorazioni simili alla loggia
Altoviti. Nelle carte degli archivi romani l'attribuzione generica
a “maestro del 1500” o a “Vasari e Zuccari” non fornisce un
valido riferimento per una reale ipotesi attributiva, ma mette in
evidenza la presenza di mani diverse. Vasari realizza per il Palazzo,
oltre agli affreschi, quattro dipinti ad olio rappresentanti le
stagioni,
da porsi in una anticamera con soffitto a cassettoni ,
opere scomparse, sembrerebbe, prima dell'esproprio.
La
pianta dello stabile realizzata in occasione della demolizione del
Palazzo Altoviti descrive con esattezza, al pian terreno, la presenza
di una sala maggiore aperta attraverso una loggia verso la cosiddetta
loggetta, luogo prospiciente
il Tevere in cui era conservato l'archivio degli Altoviti. La
grande sala o Loggia
delle statue
era accessibile esclusivamente da una seconda stanza sulla destra, di
dimensioni più ridotte. I due ambienti erano ammorsati quindi a
destra da una scala a chiocciola (Fig. 2)
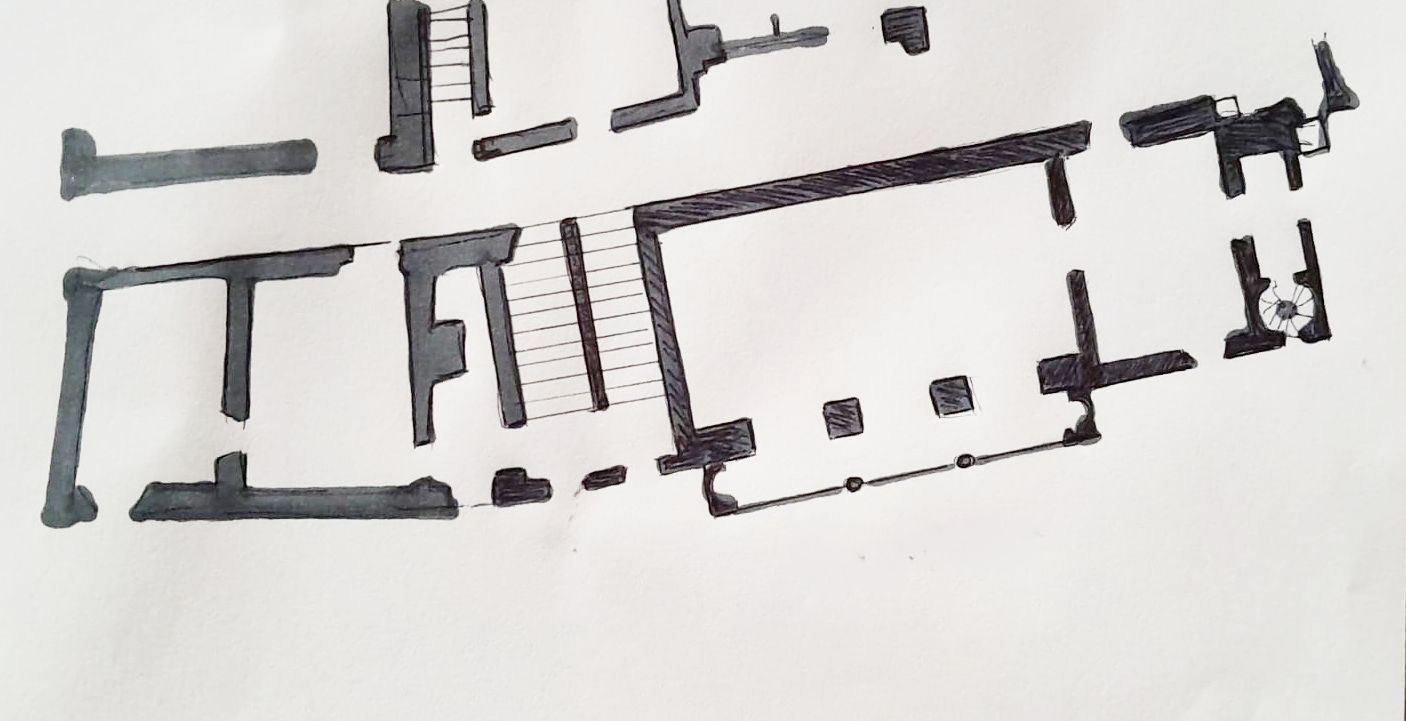 Fig. 2 - Copia della Pianta del pian terreno del Palazzo Altoviti
Fig. 2 - Copia della Pianta del pian terreno del Palazzo Altoviti
eseguita dalla Commissione Tevere ora in ACS, Roma
(Foto di C. Mochi).
e a sinistra da una grande scala regolare che però non dava accesso
alla loggia e camerino, ambienti isolati e privatissimi, con un solo
ingresso: essi dovevano rappresentare la sede del famoso Banco
Altoviti, ma ancor di più il luogo di incontro degli esuli
fiorentini, toscani costretti all'esilio perché appartenenti alla
fazione repubblicana e antimedicea.
Anima di tale gruppo fu certamente Niccolò
Ridolfi, nato a Firenze, nipote di Lorenzo de' Medici il Magnifico,
eletto a soli sedici anni cardinale (1517) e, in attesa di elezione
al soglio pontificio, morto per cause misteriose. Egli è il
destinatario del Bruto
di
Michelangelo, commissionato da Donato Giannotti, come riferisce il
Vasari. Il prelato, nella sua vigna sul Quirinale, incontra gli
illustri sodali nel viridarium,
ornato di sculture antiche e moderne: «Qui sono statue, e teste
bellissime››,
«e maschere antiche››,
ricorda Aldrovandi, disposte anche nella straordinaria biblioteca. Le
«rebus aliis etiam preciosis››
trovavano sicuramente una disposizione ordinata e pensata ,
come alcune collezioni antiquariali del Cinquecento a Roma, tra cui
quella Altoviti, in cui ornati e sculture fanno a gara con la Natura
che appare oltre le logge, dando visibilità a quel potere non solo
economico ma anche intellettuale. Questo spaccato storico, così
specifico e autentico, è documentato attraverso un'attenta lettura
iconologica dagli affreschi di Casa Altoviti;
l'Omaggio
a Cerere
di Vasari realizzato entro il 1553 celebra l'ufficio del grano e la
ricchezza familiare. Nel
1508 Bindo aveva sposato Fiammetta Soderini, cementando un'alleanza
che aveva le basi nelle tradizioni repubblicane e antimedicee delle
due famiglie, ma mantenendo comunque strette relazioni con i papi
Medici, Leone X e Clemente VII, cugini del Ridolfi. Anche se il duca
Alessandro de'Medici era stato assassinato nel 1532, durante il suo
governo tirannico, Bindo venne eletto membro del consiglio dei
Duecento. I prestiti ingenti al cardinale Ippolito de Medici, che
rivendicava il posto del duca, palesarono lo schieramento di Bindo
verso l'ala più conservatrice del fuoriuscitismo antimediceo. A
Roma Bindo Altoviti ebbe successo soprattutto con Paolo III Farnese,
che gli fruttò numerose cariche, tra cui quelle di Tesoriere della
Marca e quella di depositario
dell'abbondanza,
che segna il pieno raggiungimento della sua potenza economica nel
1554 (mentre gli affreschi di Vasari saranno eseguiti).
Gli
affreschi di Giorgio Vasari sono legati anche, probabilmente, alle
nozze tra Giovan Battista Altoviti e Clarice Ridolfi, giovane nipote
del cardinale appena citato. Nell'ovato centrale appaiono Bindo
Altoviti, padre di Giovan Battista, e Michelangelo Bonarroti,
anch'egli fuoriuscito.
Si aggiungono nei partiti monocromo il mito
di Cerere e Trittolemo,
mitico fondatore dell'agricoltura, le allegorie
di Roma e Firenze,
i Mesi
e i segni
zodiacali .
Purtroppo,
nell'opera di Giorgio Vasari rimontata a Palazzo Venezia, il
restauro in stile del partito decorativo ha variato l'organizzazione
pittorica iniziale, come riscontrabile dal confronto delle foto
prodotte prima del distacco degli affreschi dal Palazzo. Agli
originali frammenti, seppur modificati, ne sono stati aggiunti di
nuovi con l'intervento di Torello Rupelli.
Le
vele del Comune di Roma dovevano esser poste nella sala grande, a
costituire l'affaccio verso la loggetta, loggia e loggetta
comunicanti: tre grandi arcate, separate da due pilastri, decorate
con vele e sottarchi. A Marco da Faenza, come indicato da Vasari,
possono esser affidate le opere pittoriche di corredo al partito
centrale del Vasari: simili brani sono presenti in Palazzo Vecchio a
Firenze e nella casa di Vasari ad Arezzo, imprese realizzate di
ritorno da Roma. Ma è evidente che altre raffaellesche
rimasero nella loggetta e nella sala Altoviti. C'è da aggiungere
infatti che la stessa commissione di valutazione istituita per la
demolizione dello stabile ritenne diverse da quelle del Vasari alcune
decorazioni presenti nella sala, distinguendo fin da subito gli
interventi. Dobbiamo a Pietro Cecconi Principe l'impegno, e forse
l'occhio, per averle volute in parte salvare. Mi sembra difatti del
tutto improbabile che gli ambienti pubblici più importanti della
dimora Altoviti, e cioè la sua banca o la sua loggia
delle statue,
abbiano dovuto attendere Vasari per la loro decorazione. Dovremmo
piuttosto intendere questa come un restyling di un ambiente
danneggiato per l'esposizione aperta sul fiume, ma già decorato in
precedenza. L'ipotesi che gli ambienti fossero stati pensati come
appartamento dei novelli sposi (Giovanbattista e Clarice) non ci
convince pienamente, essendo quello il luogo del Banco familiare ,
accessibile dal cortile, percorso più diretto dalla strada. Tra
l'altro lo stesso Giambattista Altoviti chiama Casa
vecchia
il palazzo di famiglia del padre ,
avendo preferito risiedere fuori Porta del Popolo. Per quanto
riguarda le vele della Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma
sono certa che costituivano le aperture verso la loggetta sul Tevere;
i collaboratori di Vasari hanno di certo messo mano alle decorazioni,
ma sono queste ultime da intendersi come ripresa di un lavoro perduto
o “da restaurare”, in cui i motivi di una scuola romana vengono
ripetuti con attenzione. Nei documenti dell'Archivio Capitolino ho
recuperato in un verbale del 1890 l'attribuzione a Giovanni da
Udine ,
a cui si è aggiunta l'indicazione manoscritta di Gaspere Alveri,
in cui appare il nome di Perin del Vaga .
Anche se non possono certo questi esser considerati elementi probanti
per un'attribuzione, tali artisti sono personaggi autorevoli nel
campo delle grottesche romane, per aver lavorato spalla a spalla con
Raffaello, contribuendo all'invenzione di un genere. Ma quello che
più ha sollecitato la mia attenzione è stato ritrovare nei brani
decorativi delle vele riferimenti simbolici e allegorici che
solamente a Roma avremmo potuto trovare nel Rinascimento, sotto
l'egida del divin
pittore,
quell'amico di Bindo ritratto in gioventù quasi come un dio.
Sospese tra antichità, fanatismi antiquari ed eruditi significati,
le immagini delle vele ci portano in una parte del Cinquecento romano
che è inequivocabile: negli affreschi è dipinta la Diana
di Efeso
o Iside
multimammia (Fig. 3)
 Fig. 3 - Introdosso vele, Iside multimammia (Foto di S. Irrera)
Fig. 3 - Introdosso vele, Iside multimammia (Foto di S. Irrera)
statuetta antica e misterica alludente alla Natura e all'Abbondanza,
conosciuta nelle collezioni romane e riprodotta nelle Logge vaticane
realizzate da Raffaello e dai suoi allievi. Il destino tante volte fa
capriole e oggi l'opera, per ironia della sorte, è nelle
collezioni dei Musei Capitolini. Vasari conosce tale iconografia, a
lui certamente estranea, a Roma e forse nella casa di Bindo, tra le
grottesche del Vaticano o della sala maggiore Altoviti, in cui il
proprietario si era fatto ritrarre come Apollo, in controparte ad una
virtuosa Diana (forse sua moglie?) .
Ancora nelle vele, appare, all'interno di un clipeo, un
leone fiancheggiato da Cupido,
derivante da un'incisione di traduzione da un disegno di Giulio
Romano, discepolo di Raffaello. Tra girali, mascheroni e putti, dei
dipinti delle vele, si distingue ancora un'altra stravagante
fantasia, forse più eloquente delle altre: all'interno di una
riquadratura è visibile un leone con testa umana con la zampa
anteriore sopra ad una lumaca; (Fig. 4)
 Fig. 4 - Vele Altoviti, part. 1, leone e chiocciola
Fig. 4 - Vele Altoviti, part. 1, leone e chiocciola
Scuola Arti Ornamentali del Comune di Roma
via di San Giacomo, Roma
(Foto di S. Irrera)
leonessa e chiocciola rappresentano due elementi in opposto.
L'immagine allude senza dubbio al motto di Augusto SEMPER FESTINA
LENTE, affrettati
sempre lentamente,
utilizzato a Roma dai circoli eruditi vicini a Pomponio Leto, ma
anche da Cosimo I, come simbolo di ponderazione. Nelle opere di Marco
da Faenza, eseguite dall'artista a Palazzo Vecchio a Firenze,
appare difatti tale impresa di Cosimo I de Medici. Ma a Roma, già
prima, Paolo III Farnese (1534-1549), a cui Bindo Altoviti deve la
sua fortuna, ne aveva fatto una divisa personale. Non sembra casuale
a questo punto la presenza dell'immagine sulle vele, soprattutto se
si considera che il papa Farnese in gioventù era stato allievo del
Leto e che Marco da Faenza, l'artista che opererà a Firenze, aveva
iniziato la sua collaborazione con Vasari proprio a Roma, a Palazzo
Altoviti. Il banchiere Bindo Altoviti, che a Roma, dopo la morte del
suo Agostino Chigi non ha rivali, sceglie quel motto, che si
trasforma in divertite variazioni nelle grottesche. Le decorazioni
romane Altoviti delle vele dipendono dallo strettissimo rapporto tra
Bindo e il pontefice.
Proprio
Bindo aveva scelto come emblema personale l'allegoria della
Fortuna,
o Occasio,
rappresentata da una donna con un mantello che si gonfia al vento che
regge una colonna. Vela
e Colonna
sono raffrontati ad indicare l'equilibrio raggiunto con il lavoro
costante, la lungimiranza e la
Sapienza. Oggi appare quel simbolo, variante del Semper
Festina Lente
degli accademici romani,
un motto ancora valido e più che mai adatto anche all'intenzione
virtuosa del Comune di Roma, programmata tanti anni fa nel 1888 ed
ora finalmente compiuta.
(di
Cristina Mochi)
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
ACS,
Archivio Centrale di Stato, Roma, 2575, AA.BB.AA. II V. II S.-ACS 366
ff. 4145/4159. Roma città (Palazzi)
Min.
Pubblica Istruzione (1929-1944) (1784-1982)
Direzione
Gen. Antich. e Belle Arti (1852-1975)
Divisione
Monumenti e Scuole d'arte (1891-1897)
Docs
indicato in A. CHONG- D. PEGAZZANO- D. ZIKOS, in ACS, AABBAA,
2.2.366, fasc. 4158 (Roma città-palazzi, Palazzo Altoviti) -30 marzo
1885-19 luglio 1887
ASC,
Archivio Storico Capitolino, Roma, Commissione
Archeologica/carteggio/4° quinq. 1888-1893, busta 24/fasc. 171
bis-trasporto al Pal. Esposizioni delle pitture staccate da P.
Cecconi Principi a Palazzo Altoviti
ASC,
Archivio Storico Capitolino, Roma, Intimo
a restaurare Palazzo Altoviti,
Tit. postunitario/ tit. 62, Acque e strade/busta 5/ fasc. 60
ACS,
Archivio Centrale di Stato, Roma, Ufficio VI, serie I, b.32, fasc.
30, tit. 1891-1907.
ALDOVRANDI
1562
Ulisse
ALDOVRANDI,
Delle
statue antiche che per tutta Roma in diversi luoghi e case si veg
gono,
in L. MAURO, Le
antichità della città di Roma,
Venezia 1562, pp. 115-315, in part. pp. 141-143 (I
ed. 1556).
ALVERI
XVII sec.
Gasparo
ALVERI, La
verità,
in ASC, Cardelli-Donazione Carlo, appendice II, vol. VI, ff. 210-273,
e vol. IV, f. 363.
ALVERI
1664
Gasparo
ALVERI,
Della
Roma in ogni stato,
II, Roma 1664, pp. 103-104.
ANGIOLINO,
MOCHI 2016
Loredana
ANGIOLINO, Cristina MOCHI, La
vendita Colonna Bandini a Montecavallo,
in “De Naevia et Amore”, Stefano COLONNA,
Roma 2016, pp. 243-247.
BELLONI
1935
Coriolano
BELLONI, Un
banchiere del Rinascimento, Bindo Altoviti,
Roma 1935; Id., Dizion. storico
dei banchieri italiani,
Firenze 1951, pp. 12-14.
CHONG,
PEGAZZANO, ZIKOS 2004
Alan
CHONG, Donatella PEGAZZANO, Dimitrios ZIKOS,
Raphael,
Cellini and a Renaissance Banker. The Patronage of Bindo Altoviti,
(Boston Firenze 2003-2004)”, Boston 2004.
COLONNA
2016
Stefano
COLONNA, De
NAEVIA
ET
AMORE.
Nevia polisemantica e il mito di Bruto nella cerchia del Polifilo,
Roma, Bulzoni Editore, 2016.
DE
FILIPPIS 2017
Cecilia
DE FILIPPIS, Gli
affreschi della Scuola di Arti Ornamentali di Roma. Per una migliore
azione di tutela attraverso lo studio storico (2017),
in “Prospettive per la tutela del patrimonio culturale. Ricerche
svolte nell'ambito del Master Esperti nella tutela del patrimonio
culturale a.a. 2015-2016”, Roma 2017, pp. 91-95.
EHRENBERG
1922
Richard
EHRENBERG, Das
Zeitalter der Fugger,
Jena 1922, I, pp. 274 e 304-305.
GNOLI
1888
Domenico
GNOLI, Le
demolizioni in Roma. Il
palazzo Altoviti,
in “Arch. stor. dell'arte”,
I (1888), pp. 202-211.
GREGOROVIUS
1901
Ferdinand
GREGOROVIUS, Storia
della città di Roma nel Medioevo,
IV, Roma 1901, p. 550.
LANCIANI
1902-12
Rodolfo
Amedeo LANCIANI,
Storia
degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di
antichità,
Roma 1847-1929.
NICITA
MISIANI 2004
Paola
NICITA MISIANI,
Destruction
and Preservation: the History of the frescoes and stucchi from
Palazzo Altoviti,
pp. 263-277, in “Raphael, Cellini and a Renaissance Banker. The
Patronage of Bindo Altoviti”, Alan CHONG,
Donatella PEGAZZANO,
Dimitrios ZIKOS,
(Boston Firenze 2003-2004)”, Boston 2004.
PASQUALUCCI,
1889
Loreto
PASQUALUCCI, Il
Palazzo Altoviti, in
"Archivio storico dell'arte", Volume 1, 1889.
PASSERINI
1871
Luigi
PASSERINI, Genealogia e
storia della famiglia Altoviti,
Firenze 1871, pp. 51-52, 54-59.
PASTOR
1922
Ludwig
von PASTOR, Storia
dei Papi,
IV, 1, Roma 1908, pp. 362-363; V, ibid. 1914, pp. 737 e 758; VI,
ibid. 1922, pp. 259 e 262;
PEGAZZANO
2004
Donatella
PEGAZZANO,
Bindo
Altoviti's Ancient Sculpture,
in “Raphael, Cellini and a Renaissance Banker. The Patronage of
Bindo Altoviti”, Alan CHONG,
Donatella PEGAZZANO,
Dimitrios ZIKOS,
(Boston Firenze 2003-2004)”, Boston 2004, pp. 352-373.
RUSCONI,
VALERI 1901
Arturo
RUSCONI e Jahn VALERI (a
cura),
La vita di B. Cellini,
Roma 1901, pp. 459-461;
SLAVAZZI
2012
Fabrizio
SLAVAZZI, Nuove
ricerche su alcune collezioni romane di antichità. Altoviti,
Giustiniani, Chaen,
in “AIR, Archivio Internazionale Ricerca”, Genn. 1, 2012, pp.
101-114.
STELLA
1960
Aldo
STELLA, Altoviti,
Bindo,
ad
vocem,
in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. II, Roma 1960, pp.
574-575.
VASARI
1550
Giorgio
VASARI, Le
Vite,
ed. Firenze 1550,
a cura di Luciano BELLOSI
e Aldo ROSSI,
Torino 1986.
VASARI
1568 Vite
Giorgio
VASARI, Le
Vite,
Firenze 1568.
VASARI
1568 Ricordanze
Giorgio
VASARI, Le
Ricordanze,
ms. 30, Archivio Vasari, Arezzo.
4)
STORIA CONSERVATIVA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI STACCATI PROVENIENTI
DALLA LOGGIA DI PALAZZO ALTOVITI, CONSERVATI ALLA SCUOLA DI ARTI
ORNAMENTALI SAN GIACOMO DI ROMA
(di
Grazia Del Giudice)
“PIETRO
CECCONI PRINCIPI
DISTACCO'
QUESTE PITTURE E STUCCHI
DAL
PALAZZO ALTOVITI
PER
ORDINE DEL COMUNE DI
ROMA
NELL'ANNO 1888”.
Questo
è quanto è possibile leggere sul retro della struttura di sostegno
di alcune delle vele affrescate provenienti da Palazzo Altoviti e
conservate alla scuola di Arti Ornamentali San Giacomo di Roma. La
scritta, ad acquerello color terra d'ombra, è stata realizzata a
pennello con una bella ed ordinata grafia d'altri tempi su un
foglio di carta ormai ingiallita. (Fig. 5)
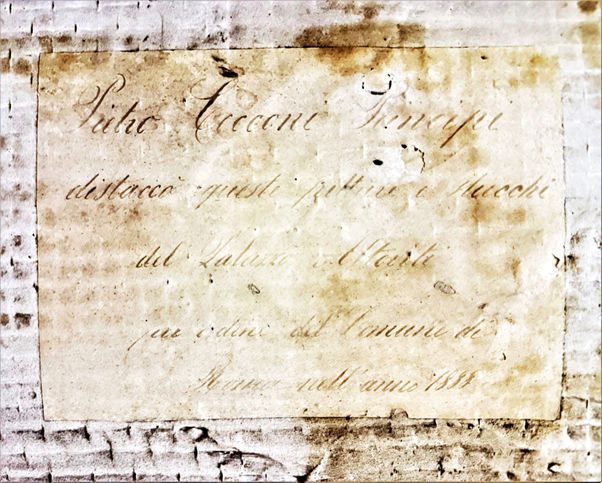 Fig. 5 - Etichetta autografa di Pietro Cecconi Principi
Fig. 5 - Etichetta autografa di Pietro Cecconi Principi
apposta sul retro della struttura di sostegno della vela n.2.
Le
strutture di sostegno delle vele e delle lunette sono realizzate in
legno, con travetti abbastanza spessi, posti a creare centine che
seguono l'andamento delle forme architettoniche del luogo
d'origine; su queste strutture lignee è stata ancorata una rete
metallica, la cui impressione è in qualche caso ancora visibile, e
sulla quale è stato colato del gesso, talvolta ricoperto di strisce
di tela o carta a completare e “compattare” l'opera di
recupero.
Ma
come si era arrivati al distacco di questi elementi architettonici
affrescati, perchè fu decisa la definitiva separazione di queste
pitture dal palazzo per il quale erano state dipinte?
Il
lavoro di smontaggio degli affreschi si era reso necessario dopo aver
deciso l'abbattimento di palazzo Altoviti, che avrebbe permesso la
realizzazione dei nuovi argini del fiume Tevere, indispensabili per
evitare pericolose inondazioni e per rendere Roma una città sicura,
funzionale e moderna. L'intervento di rimozione delle vele,
come detto, realizzato da
Pietro Cecconi Principi
alla fine dell'Ottocento, ha realmente consentito una buona
conservazione delle pitture e degli stucchi di quelle perdute
architetture, facilitandone allo stesso tempo la conservazione della
memoria delle forme originarie.
La
tecnica utilizzata da Pietro Cecconi Principi per salvare i dipinti
insieme ai loro stucchi è quella dello “stacco”, con una
procedura che troviamo documentata, in una Convenzione
stipulata con il committente Comune di Roma, -anche se non
specificatamente relativa a questo intervento, ma ad un altro
importante intervento da lui realizzato insieme a Giuseppe Missaghi
nel 1875, lo stacco dell'affresco della Storia di Psiche a Palazzo
Pallavicini Rospigliosi- ma che presumibilmente è la stessa
procedura utilizzata in questo caso:
“Si
procede da prima col pulire e rinettare… con ogni diligenza
l'affresco, quindi si prosegue col distaccare dal muro di un sol
pezzo ognuna delle suddette pitture con tutte quelle pratiche e
diligenze che l'arte consiglia, pareggiare il muro d'intonaco per
di dietro fino a quella grossezza che il direttore crederà
necessaria per la buona riuscita del lavoro, di attaccarle poi ognuna
su n. 2 tele forti e nuove con tenace colla su tutti i punti
egualmente assicuratile su forti telai di legno stagionato bene
intestati e con il numero delle crociate che la loro grandezza
esigerà per sicurezza. Scoprirle poi e tornare a nettarle con
diligenza, e farvi sopra qualunque altro lavoro anche di pennello
esclusa però qualunque sostituzione di parte mancante, porvi dei
regoli attorno o tutt'altro necessario a portarle nel luogo che
verrà destinato alla loro collocazione, ove verranno consegnate”.
Lo
“stacco a massello” era una tecnica antichissima, ampiamente
utilizzata fin dai tempi dei Romani, che permetteva di staccare le pitture murali insieme al loro supporto di intonaco e a tutto o a parte del loro supporto murario, di trasferirle su pannelli per salvarle dalla distruzione dovuta all'abbattimento
o all'adeguamento stilistico dei luoghi per cui erano state create.
Lo
“stacco” invece prevedeva la rimozione del solo intonaco, che veniva poi ulteriormente assottigliato e pareggiato dal retro una volta staccate le pitture. A Roma
la tecnica dello stacco aveva raggiunto il massimo sviluppo
tecnologico nella prima metà del Settecento grazie a Niccolò
Zabaglia ,
al quale è dedicata, non a caso, una delle quattro Scuole di Arti e
Mestieri del Comune di Roma.
Sul
finire del secolo purtroppo, a questa tecnica fu gradualmente
preferita la traumatica tecnica dello “strappo”, che permetteva
di trasferire su tela non pittura e intonaco insieme, ma la sola
pellicola pittorica di superficie, “strappandola” letteralmente
dal supporto su cui era stata originariamente dipinta, e trasformando
così pitture nate appositamente per un luogo specifico e dunque
legate indissolubilmente ad esso, in veri e propri quadri su tela che
venivano poi facilmente rivenduti come opere d'arte in sé.
Lo
stacco e lo strappo degli affreschi diventarono un modus
operandi
fino a quando la Commissione Generale Consultiva di Antichità e
Belle Arti, organo di tutela dello Stato Pontificio, e l'Accademia
di San Luca, cominciarono ad opporsi alle richieste di privati
cittadini di poter distaccare i dipinti di loro proprietà .
Qualunque distacco, dal 1839, doveva infatti essere soggetto ad
un'autorizzazione preventiva, e agli “estrattisti” venne
notificato il divieto di eseguire trasporti non autorizzati.
Per
fortuna, nel caso di Palazzo Altoviti, grazie all'interesse e alla
lungimiranza di Domenico Gnoli,
che riconobbe la bellezza e l'importanza degli antichi
affreschi che lo decoravano, si riuscì a salvare dalla distruzione
alcune delle pitture, e lo si fece mediante la tecnica dello
“stacco”, tecnica molto meno invasiva e più rispettosa della materia originale rispetto a quella dello “strappo”.
Nel
1887, in vista dell'abbattimento, era stato firmato l'accordo per
l'esproprio del Palazzo, che si affacciava sul Tevere all'altezza
di Ponte Sant'Angelo, presso San Giovanni dei Fiorentini. Per
fortuna, la cosa attirò l'attenzione di studiosi e tecnici, così,
prima che venissero avviati i lavori di demolizione, il Ministero
della Pubblica Istruzione (che a quel tempo aveva anche competenze e
funzioni relative alle Antichità e Belle Arti), chiamò l'
”estrattista ”
Cecconi Principi a “staccare” alcune delle antiche pitture e
degli stucchi, Le
Storie di Cerere e il ciclo dei Mesi,
realizzate dal Vasari per Bindo Altoviti nel 1553.
Nella
lettera di collaudo che il direttore dell'Istituto di Belle Arti
inviò alla Direzione Generale, si dichiara che il Cecconi Principi
aveva “distaccati e riportati su tela 23 affreschi della volta di
una sala” ma anche, di sua iniziativa, aveva distaccato alcune
decorazioni non comprese nella lista dei dipinti da conservare e che,
altrimenti, sarebbero andate distrutte.
Gli
affreschi vennero smontati, su commissione del Ministero, da due
importanti ambienti del Palazzo, la loggia ed il camerino, per essere
poi ricoverati a Palazzo Corsini alla Lungara, in attesa di dare loro
una nuova collocazione e dunque una nuova vita. Le pitture della
volta furono poi rimontate a Palazzo Venezia nel 1929 dove sono
tuttora, nella Sala Altoviti, ex sala Pisana dell'appartamento
Cybo. Ma altre decorazioni ad affresco, quelle oggetto di questo
saggio, destinate alla distruzione insieme al Palazzo per cui erano
state create, vennero salvate grazie al Comune di Roma, che sollecitò
la Direzione Generale Antichità e Belle Arti a provvedere alla
conservazione di ogni “oggetto
pregevole per arte o per antichità che si rinvenisse nella
demolizione di quell'edificio ”.
Fu
così che vennero fortunatamente sospese le demolizioni, affinchè
Pietro Cecconi Principi potesse staccare e quindi salvare, in questo
caso non più per il Ministero ma questa volta per il Comune di Roma,
le decorazioni a grottesche
che decoravano la saletta e l'attigua loggetta, e che da allora
sono conservate nella Scuola di Arti Ornamentali San Giacomo.
Nell'inventario
di consegna del 18 aprile 1890, “Nota
delle pitture distaccate dal Sig. Pietro Cecconi Principi nelle
demolizioni del Palazzo Altoviti ,
esistenti ancora in via degli Incurabili
n.10, proprietà del Comune, sotto tutela del Sig.Principi”,
si elencano:
N.°
3 archi con velette con ornati e figurine formanti due pezzi ognuno.
N.°
3 Lunette con velette, eguali ornati, in due pezzi ciascuno come
sopra.
N.°23
frammenti con figurine ed ippogrifi.
A
conferma dell'avvenuta consegna degli affreschi staccati, il 21
aprile 1890 l'ispettore del Comune inviava al Sindaco una lettera
in cui comunicava che i dipinti staccati erano:
“tre
archi con sue velette, e tre lunette, due de'quali mancanti di
pitture nelle punte.
I
dipinti sono opera del 1500 di autore incognito, ove sono
rappresentati fogliami, maschere, figurine, ed animali fantastici ben
conservati ”.
Le
vele con motivi decorativi a grottesche, insieme alle loro cornici in
stucco, erano state staccate dalla sommità delle pareti laterali
della sala terrena, in prossimità dell'attigua loggetta ,
i sottarchi formavano probabilmente l'imbotte delle porte-finestre
centinate di passaggio tra sala e loggia e provenivano quindi dal
lato occupato dalle finestre prospicienti la loggetta sul Tevere,
mentre le lunette ellittiche, due con fondo ocra ed una a fondo
rosso, contenevano probabilmente piccoli busti a tutto tondo,
racchiusi in cornici di stucco ovali, ed oggi risultano prive di
decorazione.
Dei
23 frammenti con figurine ed ippogrifi, menzionati nella lista delle
opere consegnate, si sono purtroppo perse le tracce ,
molto probabilmente per la maggiore facilità con cui potevano essere
commerciati, rispetto alle strutture delle vele, delle lunette e dei
sottarchi, che, fortunatamente, furono destinate con fini didattici
alla Scuola d'Arte Ornamentale San Giacomo di Roma, dove sono
conservate da allora.
In
questa sede, sul finire del secolo, venne dunque deciso di allestire
le strutture affrescate a soffitto, nell'aula di Affresco, così da
poter rimanere a disposizione degli allievi per lo studio delle
tecniche e come fonte di ispirazione per la creazione dei loro
lavori.
Per
circa 120 anni queste opere rimasero dunque relativamente al sicuro,
stabilmente ancorate al soffitto ligneo cassettonato del Laboratorio
di Affresco, fino a quando furono decisi interventi di
ristrutturazione e di adeguamento degli impianti della scuola .
Le vele vennero così smontate e trasferite in sala conferenze, al
piano terra del palazzo, in attesa di essere restaurate e riallestite
in quella stessa sala.
Gli
interventi di restauro sulle vele furono condotti dalla professoressa
Gabriella Gaggi
insieme agli allievi del Corso di Perfezionamento del Restauro di
dipinti, stucchi e lapidei da lei tenuto negli anni dal 2015 al 2017.
Purtroppo, in quell'occasione non venne condotta una specifica
campagna diagnostica, dunque, ci si basò su un'indagine visiva per
descriverne la tecnica esecutiva:
l'intonachino
risulta essere composto da calce, sabbia e polvere di marmo, così
come gli stucchi modanati.
La
superficie degli affreschi appare ben levigata, e in qualche zona
risultano ancora visibili i segni degli strumenti utilizzati per la
stesura dell'intonaco.
Prima
di dipingere, l'artista ha tracciato i disegni preparatori, che
sono stati trasferiti mediante incisioni per lo più dirette, cioè
senza interposizione del cartone, lasciando tracce incise che
appaiono direttamente eseguite sull'intonaco e che sono servite
principalmente ad inquadrare geometricamente la composizione. Sono
inoltre visibili i segni dello spolvero, altro metodo di
trasferimento del disegno, utilizzato per ripetere velocemente i
motivi decorativi ad ornato. L'esecuzione pittorica rispetta in
linea generale le tracce disegnative, anche se la stesura del colore
viene effettuata con una certa libertà e velocità.
I
pigmenti utilizzati sono quelli compatibili con l'affresco: ocra
gialla e rossa, terra verde, bianco sangiovanni, morellone. Gli
stucchi di marmorino comprendono fasce modanate con motivi “a
perline sferiche”, a “ovuli e dentelli” e a “foglie”,
impreziositi su alcune delle fasce dalla doratura.
Prima
dell'intervento di restauro gli affreschi apparivano in un discreto
stato di conservazione, nonostante le diverse lacune ed abrasioni
presenti in maniera generalizzata un po' su tutta la superficie e
nonostante le numerose mancanze di superficie dipinta, le più estese
delle quali ritroviamo nella zona delle punte di due delle tre vele
-così come descritto esattamente nel 1890 dall'ispettore del
Comune al Sindaco (vedi nota 12) -
e dovute in gran parte alle conseguenze dello “stacco” subìto.
L'intervento di restauro è stato condotto cominciando con una
depolveratura effettuata con aspiratore e pennello morbido. Dopo una
prima pulitura condotta a secco per eliminare i depositi di
particellato, sono stati effettuati alcuni piccoli interventi di
preconsolidamento nelle zone in pericolo di caduta. A questo punto è
stato possibile avviare l'operazione di pulitura della superficie
affrescata con una soluzione satura di acqua e carbonato di ammonio
passata a pennello con interposizione di carta giapponese.
La
pulitura degli stucchi è stata condotta principalmente a secco, con
l'utilizzo di solventi specifici previamente testati solo su alcune
zone molto circoscritte.
Dopo
aver pulito e consolidato l'intera superficie, si è proceduto con
la stuccatura delle lacune e delle fessurazioni e al rifacimento
delle porzioni di intonaco mancanti, con una malta composta da
polvere di marmo di fine granulometria e calce, con l'obiettivo di
ripristinare la continuità strutturale ed estetica e di rendere la
superficie più stabile e leggibile. Anche questa operazione è stata
effettuata scegliendo materiali compatibili con i materiali
costitutivi originali del dipinto. Il criterio utilizzato per il
livello delle stuccature, la lavorazione della texture superficiale e
il loro cromatismo (a tono o sottotono) sono state valutate caso per
caso. Per completare le cornici laddove mancanti sono stati
realizzati calchi in silicone per riprodurre i motivi ornamentali da
integrare plasticamente.
L'integrazione
pittorica è stata condotta, con metodo riconoscibile e reversibile,
a “punta di pennello” con acquerelli Winsor &Newton; per
l'integrazione dell'oro degli stucchi le tonalità utilizzate
sono state ocra gialla, terra d'ombra naturale, rosso indiano e
verde cromo. Le vele hanno così ritrovato stabilità, armonia
cromatica e leggibilità. Oggi finalmente, dopo tanti anni, grazie al
bel progetto di allestimento curato dall'architetto Franco Bernardini
e, soprattutto, grazie all'energia e all'impegno del Comune di
Roma e della Direzione delle Scuole Arti e Mestieri, in
collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio di Roma, gli archi e le lunette, in coppia con le loro
rispettive vele, sono state ricollocate nel Salone al pian terreno,
da oggi denominato
Sala delle Vele.
(di
Grazia Del Giudice)
NOTE
BIBLIOGRAFIA
CECCHINI
1908
Silvia
CECCHINI
(a cura di), Archivio storico nazionale dei Restauratori italiani.
Banca dati, codice identificativo scheda 3/2/70 Pietro
Cecconi Principi,
Roma s.d.- 1908, prima notizia 1870.
ARCHIVIO
STORICO CAPITOLINO
GIACOMINI
2014
Federica
GIACOMINI, Il
distacco dei dipinti murali a Roma dal Cinquecento all'Unità
d'Italia,
catalogo della mostra “L'Incanto dell'affresco”, Ravenna,
MAR, 2014, vol. 2.
GNOLI
1888
Domenico
GNOLI, Le
demolizioni in Roma: il Palazzo Altoviti,
in “Archivio storico dell'Arte”, 1888.
HERMANIN
1948
Federico
HERMANIN, Il
Palazzo di Venezia,
Roma, 1948.
MARCONI
2004
Nicoletta
MARCONI, Castelli
e ponti, apparati per il restauro nell'opera di maestro Nicola
Zabaglia per la fabbrica di San Pietro in Vaticano, Foligno,
2004.
NICITA
MISIANI
2003
Paola
NICITA MISIANI,
La
ricostruzione degli affreschi della loggia Altoviti nel Palazzo di
Venezia tra conservazione e invenzione,
in “La volta vasariana restaurata”, 2003.
NICITA
MISIANI 2003
EID.,
Destruction
and preservation. The history of the frescos and stucchi from Palazzo
Altoviti, in Raphael, Cellini and a renaissance banker. The patronage
of Bindo Altoviti,
catalogo della mostra, Milano, 2003.
SCONCI
2003
Maria
Selene SCONCI (a cura di), Il
restauro degli affreschi della volta Altoviti,
Roma, 2003.
|