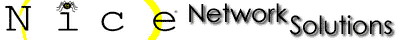Il materiale che qui verrà presentato e discusso, è
costituito
dalla suppellettile ceramica, cosiddetta non germanica,
proveniente dai corredi funerari delle necropoli longobarde di
Nocera Umbra e Castel Trosino , e ora conservata a Roma nel Museo
dell'Alto Medioevo, e da un'altra classe ceramica, quella delle
invetriate altomedioevali in Italia, ancora assai poco nota, al di
fuori almeno di certe aree topograficamente e culturalmente
delimitate, e ciò per la scarsezza di dati archeologici
provenienti da contesti sicuri.

CERAMICA COSIDDETTA "BARBARICA"
Prima di iniziare il discorso con la rassegna delle ceramiche
rinvenute nelle necropoli longobarde di Nocera Umbra e di Castel
Trosino, entrambe per la maggior parte conservate nel Museo
dell'Alto Medioevo a Roma, sarà opportuno, come nota preliminare,
accennare alla produzione di ceramica nell'Europa centrale e
meridionale.
Per quanto riguarda il periodo delle migrazioni, disponiamo di
tre gruppi di ritrovamenti di ceramiche:
1) ritrovamenti
provenienti da fabbriche di ceramica;
2) ritrovamenti da
insediamenti;
3) ritrovamenti tombali.
Per il periodo che a noi interessa, il primo gruppo risulta
essere rarissimo: in Italia manca completamente, mentre in
Germania se ne conoscono solo alcuni. Per quanto riguarda il
secondo gruppo, quello relativo alle ceramiche provenienti da
antichi insediamenti, i ritrovamenti e la loro valutazione
risultano estremamente difficili, per il fatto che i centri
abitati di quell'epoca si trovano normalmente sotto villaggi o
città moderne. Il terzo gruppo, quello cioè relativo a
vasi
provenienti da tombe, rappresenta indubbiamente la fonte più
adatta per lo studio delle ceramiche.
Si comincerà dal territorio delle Province Romane, nella parte
sud-occidentale del regno merovingio, per poi occuparci della
situazione in Italia.
Il cimitero franco-renano di Krepfeld-Gallep ci offre, per
l'altomedioevo, un panorama abbastanza soddisfaciente della
produzione di ceramica nella Renania. Il cimitero risale al
periodo romano e continua ad essere ininterrottamente usato fino
alla fine del VII secolo. Le tombe romane contenevano il tipico
corredo di vasi. Questa ceramica della fine del III e del IV
secolo proviene, quando si parla di terra sigillata, dalle
Argonne; il vasellame di uso casalingo proviene invece da Majen
nell'Eifel. Le fabbriche di Majen, o per meglio dire i forni,
furono trovati nei dintorni della città, come anche furono
ritrovati cumuli di cocci (nulla è stato pubblicato su gran parte
di questo materiale).
Invece dalle Argonne proviene il gruppo della cosiddetta
"sigillata a rotelle", zona dove si erano istallate diverse
fabbriche di tradizione romana. Era lì che veniva prodotto
l'ultimo tipo di terra sigillata. La ceramica prodotta da queste
fabbriche è in massima parte decorata. Queste decorazioni furono
incise con rotelline nella creta ancora fresca, e furono proprio
queste rotelline a dare il nome a questa classe di ceramica.
La "sigillata a rotelle" ha avuto un ampia diffusione e ne sono
stati trovati esemplari anche in luoghi abbastanza lontani dai
centri di produzione. All'inizio del V secolo questa usanza
subisce un cambiamento: nel periodo che segue vediamo che le tombe
racchiudono suppellettili di ceramica locale, ma soltanto un
esemplare o al massimo due per ogni tomba. I vasi non sono più
esclusivamente prodotti di massa provenienti da fabbriche. Sembra
che l'origine di queste nuove forme sia da ricercarsi in quella
parte della Germania che si trova a destra del Reno.
A partire dalla fine del IV secolo si ferma la vera e propria
produzione di ceramica romana eccetto quella delle fabbriche di
Majen. Quindi si attesta una nuova produzione locale fino al
predominio - alla fine del VI sec. - della cosiddetta ceramica
franca, proveniente in parte da botteghe di vasai locali e in
parte da imprese più ampie. Questa produzione elabora una nuova
forma caratteristica di recipiente, conosciuto con il nome di vaso
biconico franco.
La decorazione di questi vasi, chiamati per la loro lavorazione
"ceramica lucida a cottura riducente", consiste in una serie di
incisioni a rotelline o a stampo o a linee ondulate incise con
pettine. La zona di maggiore diffusione si trova intorno al Reno,
ma particolarmente nella Renania centrale. Tutti questi vasi sono
esemplari del VI e del VII secolo.
Un altro gruppo di vasellame, prodotto anch'esso sempre nel VI e
nel VII secolo è quello comprendente i cosiddetti vasi alemannici
con costolature a sbalzo (Rippen oder Buckelgefaesse). Ci si è
resi conto che questi vasi costituivano un fenomeno della moda del
IV e V secolo estesasi a tutta l'Europa nord occidentale.
La quantità dei ritrovamenti diminuisce più tardi, mentre
per quanta riguarda le zone alemanniche, la maggior parte di questi
vasi è da far risalire al VII secolo.
Il terzo prototipo di ceramica di epoca merovingica, proviene
dalla Germania meridionale (questa particolarmente importante
perchè direttamente connessa con la ceramica longorbarda trovata
in Italia, di cui si dirà di seguito).
Si tratta di bicchieri e vasi a forma di otre. Questo tipo di
vasi non è di provenienza occidentale, bensì di origine
orientale.
Tali recipienti a forma do otre, sono quasi sempre decorati da
stampigliature e vengono modellati a mano. La loro tipologia
richiama il gruppo principale della ceramica longobarda in Italia,
con la differenza che quest'ultima è modellata al tornio.
Questi i tipi principali e più diffusi di ceramica prodotta nel
VI e nel VII secolo in Renania e nella Germania sud occidentale.
Naturalmente accanto ai prototipi descritti sopra, sono esistite
ceramiche diversissime nella stessa epoca e nella stessa zona, in
genere prodotti di piccole botteghe probabilmente molto numerose.
Dopo aver parlato della ceramica transalpina dell'epoca delle
migrazioni passiamo ad occuparci della ceramica in Italia.
L'analisi verterà principalmente sulla produzione della ceramica
dell'Italia settentrionale e centrale, in quanto per l'Italia
meridionale ancora non si è presa una posizione critica nei
confronti del materiale rinvenuto.
Presenza di forni di vasai oppure di fabbriche di ceramica del
periodo in esame sembra non essere attestata.
D'altronde è presente la ceramica di insediamento, ma molti dei
ritrovamenti rimangono ancora da datare e classificare (nella
maggior parte dei casi si tratta di ceramica senza alcun intento
artistico, decorata nel modo più semplice, a graffio).
Rimane così, per i nostri scopi, l'ultimo gruppo di ceramiche,
quelle provenienti da tombe e legate al rito funebre. Sappiamo che
il popolo latino non usava suppellettile tombale. Pertanto
dobbiamo la nostra conoscenza di ceramica tombale alle tribù
barbariche e soprattutto a quelle longobarde, le quali per alcuni
decenni dopo la loro discesa in Italia, continuarono a conservare
le usanze connesse al rito funebre, come l'uso delle suppellettili
tombali. In In genere questi vasi provenienti da sepolcreti si
possono dividere in due gruppi: 1) ceramica propriamente
longobarda; 2) ceramica di tradizione tardo-antica che fu
prodotta nelle botteghe romane in Italia.
Per quanto riguarda la ceramica longobarda, parliamo soprattutto
di recipienti per bere (servizi di bottiglie, caraffe e
bicchieri). I tipi principali di questo gruppo di ceramica
modellata col tornio sono le brocche con becco, le bottoglie e i
bicchieri a forma d'otre e le bottiglie a collo lungo. La
decorazione è con stampigliature e motivi licidi. E' chiara la
derivazione di tale ceramica da quella sviluppata dai Longobardi
in Pannonia. Se non si conoscono le reali influenze, è sicuro
invece che la cosiddetta ceramica longobarda in Italia fu una
concreta produzione dei Longobardi. La distribuzione dei luoghi di
ritrovamento in territorio longobardo nell'Italia settentrionale
ne è una conferma (Friuli, necropoli di Cividale, Veneto,
Lombardia, Piemonte, necropoli di Testona-Moncalieri).
Nell'Italia centrale invece la situazione è diversa: da questo
luogo infatti proviene un tipo di ceramica molto diverso. Le zone
interessate sono soprattutto Umbria e Toscana. I cimiteri che
attestano questo materiale fittile sono quelli di Nocera Umbra e
Castel Trosino (questo nella regione Marche), Arcisa (vicino
Chiusi) e Fiesole.
La parte maggiormente testimoniata di questi ritrovamenti è
formata da brocche, boccali con orlo a trifoglio. Di particolare
importanza la presenza di piatti e di scodelle con orlo a listello
in sigillata chiara D, di fabbricazione africana, che compaiono
come manufatto di lusso nelle tombe più ricche del VII secolo.
Tutti i recipienti di questo gruppo sono del tipo molto duro,
ottenuto con una cottura speciale e superficiale ruvida, e con una
gamma di colori che va dal grigio all'ocra, passando per
l'arancione. La decorazione manca in quasi tutti i vasi e dove
compare è rappresentata da alcune linee ondulate incise con il
pettine.

NECROPOLI DI NOCERA UMBRA E CASTEL TROSINO
Non ci resta ora che analizzare il materiale ceramico rinvenuto
nelle due maggiori necropoli longobarde di Nocera Umbra e Castel
Trosino, avvalendoci del lavoro, completo nel suo insieme, di I.
Baldassarre
(1)
, la quale ha cercato, per quanto possibile, di
inquadrare tale materiale ceramico nell' economia della produzione
di età longobarda in Italia. Possediamo una sommaria sistemazione
cronologica del materiale ceramico grazie alla presentazione
fornitaci dai primi editori delle necropoli stesse
(2) .
È ovvio però che un inquadramento valido e completo di questa
classe di ceramica potrà scaturire solo dalla catalogazione e
dalla pubblicazione sistematica di tutto il materiale di età
barbarica presente nei musei italiani.
Brevi notizie sulle singole necropoli non potranno che risultare
di necessaria premessa.
La necropoli di Nocera Umbra fu scoperta nel 1897. Le tombe
esplorate, di numero 165, erano disposte senza ordine topografico
tra sepolcri ricchi e poveri. Le ceramiche furono trovate in 44
tombe, mai più di un pezzo per tomba, e appartengono generalmente
a sepolture di donne e bambini. Delle 44 ceramiche citate nella
relazione di scavo, 26 sono ora conservate a Roma nel Museo
dell'Alto Medioevo, e di queste solo 5 sono fruibili al pubblico e
saranno qui elencate e descritte; le rimanenti si trovano o nei
magazzini del museo in attesa di una nuova sistemazione, o a
Milano, insieme a tutto il corredo tombale; in parte sono andate
invece distrutte nella fase di recupero.
Grazie alla datazione di monete rinvenute sul luogo (aurei di
Giustiniano), si può con sicurezza attribuire l'inizio della
necropoli all'anno 5713 (cronologia determinata anche dal
ritrovamento di fibule longobarde di I e II stile): il sepolcreto
fu attivo quindi dall'ultimo trentennio del VI secolo con un
prolungamento nel VII secolo, e con un addensamento delle
sepolture intorno al 600.
a) Ciotoletta di terracotta rosso vivo su basso piede ad anello;
bordo sagomato, incavo centrale all'interno; rotta in due parti e
restaurata.
Noc.U., tomba 23; inv. n.299 (2184) Misure: alt.0,05; diam. max.
0,185
b) Brocchetta di terracotta, molto compatta, color nocciola;
corpo globulare schiacciato su base piatta; corpo sottile e in
rapporto al ventre piuttosto lungo; labbro verticale sagomato con
bordo ingrossato leggermente trilobato. Intera.
Noc. U., tomba 39; inv. n.447
Misure: alt.0,135; diam. max.0,14
c) Grande piatto di terracotta rossa, su basso piede ad anello e
con bordo sagomato; scarse tracce di ingubbiatura biancastra;
ricomposto da vari frammenti.
Noc. U., tomba 60(donna); inv. n.630(2413)
Misure: alt.0,06; diam. max.0,24
d) Vasetti gemelli, di colore grigiastro, decorati con file di
rosette impresse; corpo piriforme, senza piede e bocca svasata.
Esempio unico in Italia centrale di ceramica nera stampigliata,
tipica dei popoli germanici, che i longobardi hanno lasciato nelle
tombe pannoniche, trovata anche in sepolture dell'Italia sett.
Noc. U., tomba 148; inv. n.1102
Misure: alt.0,20; diam. max.0,10
La necropoli di Castel Trosino fu scavata nel 1893-96. Si tratta
in questo caso di tre necropoli adiacenti: S.Stefano, Contrada
Fonte, Contrada Campo.
Le tombe venute alla luce furono 237, di numero maggiore quindi
rispetto al precedente sepolcreto, ma in generale più povere. Le
ceramiche erano 45, anche qui sempre una per tomba: 27 sono ora
conservate nel Museo dell'Alto Medioevo e di queste solo 5 sono
esposte al pubblico e saranno qui descritte.
Le rimanenti si trovano anch'esse in casse poste nei magazzini
del museo o sono in frammenti o addirittura non raccolte dagli
scavatori perchè trovate in frantumi. Anche qui l'ausilio delle
monete (aurei di Anastasio I, 491-518, a Maurizio TIberio, 582-
602) permette di collocare nell'anno 578 l'inizio di questa
necropoli
(4). Iniziata quindi negli ultimi decenni del VI secolo,
ebbe però un tempo di durata più lungo che a Nocera,
continuando per tutto il VII secolo. Numerose tombe sono prive di qualsiasi
suppellettile, e non è stato rinvenuto alcun esemplare di ceramica
nera stampigliata cosiddetta "longobarda".
a) Grande piatto circolare in terracotta rossa friabilissima, su
basso piede ad anello, con orlo sagomato; all'interno lieve
depressione nella parte centrale; ricomposto da diversi frammenti
integrato parzialmente nell'orlo.
C. Tr., tomba F; inv. n.1202(1944)
Misure: alt.0,055; diam. max.0,32
b) Boccaletto di terracotta rosso vivo con molte impurità; corpo
ovoidale col maggiore diametro piuttosto in basso; breve collo e
labbro sagomato verticale; ansa a cordone impostata sotto il labro
e sul ventre; tracce di vernice di un rosso scuro; danneggiato da
un foro oblungo poco al di sotto dell'ansa; rotta leggermente nel
labbro; restaurata parzialmente nel ventre.
C. Tr., tomba 31(donna); inv. n.1360
Misure: alt.0.18; diam. max.0,13
c) Brocchetta di terracotta giallo paglierino; corpo quasi
cilindrico su base piatta; collo breve e stretto, leggermente
svasato, labbro non sagomato; l'ansa è impostata sotto il labbro e
nella spalla; presenta solchi paralleli orizzontali sotto l'ansa,
con tracce di vernice rossa nella zona dei solchi; mancano parte
del collo e del labbro.
C. Tr., tomba 32(donna); inv. n.1366
Misure: alt.0,195; diam. max.0,10
d) Grande piatto di terracotta rossa; molto friabile, su basso
piede ad anello con orlo sagomato; rotto in quattro frammenti,
ricostruibile; reca tracce di ingubbiatura più scura.
C. Tr., tomba 90; inv. n.1458(1945)
Misure: alt.0,60; diam. max.0,38
e) Anforetta di terracotta rossa depurata; corpo ovoidale
slanciato su piede ad anello sagomato; collo lungo e stretto
leggermente svasato verso l'alto, con labbro leggermente
ingrossato; due grandi anse a cordone, simmetriche, sono impostate
a metà collo e sulla spalla; ricomposta da frammenti.
C. Tr., tomba 121(giovinetta); inv. n.1623(1419)
Misure: alt.0,18; diam. max.0,08
Come abbiamo visto, la forma che ricorre più frequentemente è
il boccale, ma compaiono anche altre forme, come le olle panciute, le
ciotole, le anforette. In una povera tomba nella necropoli di
Castel Trosino, si è rinvenuto un askòs di terracotta in forma
di animale a quattro zampe (tomba 114); in un altra una rozza
lucernetta (tomba 37).
Vorrei ora brevemente accennare, per completare il quadro sulle
necropoli longobarde del centro Italia, al rinvenimento del
materiale caramico nel cimitero di Pettinara-Casale Lozzi (Nocera
Umbra), scavato nel Maggio 1976, in occasione della costruzione di
una abitazione presso l'attuale piazza delle Medaglie D'oro.
I pochi reperti di queste tombe mostrano, senza dubbi, che anche
questo cimitero era probabilmente longobardo e senz'altro di epoca
longobarda. Complessivamente sono state scavate 41 tombe, ma si
pensa che almeno 80 siano andate perdute.
Tutti i recipienti trovati a Pettinara, ad esclusione di una
piccola brocca, appartengono ad un tipo finora poco noto, che può
al massimo essere paragonato alla "pignatella"
(5) .
Si tratta di bricchi sferici con un manico. Sul corpo del
recipiente posa verticalmente il bordo basso e tondo, senza che vi
sia frammezzo il collo. I vasi sono cotti bene e di vari colori, e
risultano inoltre piuttosto pesanti.
In base alla tradizione del corredo funebre di ceramica
dell'alto medioevo, deve trattarsi di recipienti usati per bere
ma, per la forma e la fattura, potrebbero essere anche pentole.
Non si hanno punti di riferimento validi per la datazione.
Il recipiente della tomba 65 di Nocera Umbra somiglia più degli
altri a questa tipologia di vasi. La piccola brocca della tomba 7,
che fa parte di questo gruppo, ha forma sferica e collo corto,
sottile e rientrante; il bordo non esiste più. Per questo pezzo di
tradizione antica si ha come esempio un reperto analogo,
proveniente dalla tomba 93 di Nocera.
Dalla tomba 35, sempre di Pettinara, proviene il coccio di un
vaso relativamente grande e di forma imprecisata, di ceramica
rossa ben cotta. Presenta scannellature uguali e parallele e
appartiene ad una tipologia di ceramica tardo-antica
altomedioevale: la si trova spesso negli strati più recenti di
caverne e grotte, che fornivano rifugio alla popolazione in quei
tempi agitati. Purtroppo non è possibile datarla con precisione.
Altri frammenti di anfore furono trovati durante lo scavo, ma
certamente non hanno rapporto con la necropoli stessa.

CONSIDERAZIONI GENERALI
Ad un esame complessivo il materiale può essere diviso in due
grandi classi: in gran parte si presenta grossolano, povero di
forme, di impasto non depurato e di cottura imperfetta.
Domina su tutto la mancanza di ripetizione delle forme, a
sottolineare quasi l'assenza di una fabbrica artigianale che
producesse prodotti in serie. Da ciò si distaccano, come classe a
sè, i pochi pezzi di argilla compatta, buona cottura e con
ripetizione esatta delle forme, che riecheggiano modi di antica
tradizione.
In definitiva, e si pecca di genericità, tale prodotto ceramico
viene complessivamente considerato, esclusi i pezzi germanici, una
continuazione dell'industria locale italica, della quale i
Longobardi si sarebbero serviti e non si discosterebbe per tecnica
e forma, da prodotti usuali del periodo tardo-antico.
Comunque, per centrare veramente il problema, bisognerebbe
analizzare quale fosse la tradizione tecnica e la realtà economica
prima del contatto con i Longobardi, e quale fu il reale apporto
artigianale longobardo con cui i romani vennero in contatto.
Conosciamo tutti la crisi economica , sociale e politica che
l'Italia attraversò nei secoli VI e VII. Consideriamola ora in
rapporto alla produzione ceramica.
Dal punto di vista archeologico constatiamo la scomparsa della
produzione artigianale organizzata in fabbriche: per mancanza o
limitatezza di mezzi si ha la tendenza a chiudersi in produzioni
locali, con una circolazione interna, e con una diminuita esigenza
di commercio a grande raggio. Non esistenndo più domanda di
mercato, vengono meno anche quelle innovazioni tipologiche e
ornamentali che ci permettevano, con le loro variazioni, di
seguire un iter cronologico e stilistico.
A sottolineare ancora maggiormente il perduto interesse
artistico, la suppellettile ceramica diviene di tipo domestico,
ridotta al necessario e soprattutto di uso quotidiano. Una
precisazione però va fatta: non siamo in presenza di un fenomeno
esploso improvvisamente nel VI secolo; anzi, già nel periodo
tardo-antico assistiamo ad un progressivo decadimento della
prodizione ceramica.
I primi segni sono riconducibili a cominciare dal III-IV secolo,
dove assistiamo ad una progressiva eliminazione di motivi
decorativi, ad uno scadimento della vernice e ad una diminuzione
di forme, per arrivare ai secoli IV-V, la cui caratteristica è un
irrigidimento di forme, che avranno però la particolarità
di conservarsi a lungo. Alla terra sigillata, come ceramica fine, si
sostituirà probabilmente nel V-VI secolo la ceramica invetriata:
è da notare, comunque, che questa classe di ceramica non
è presente nelle necropoli prese in considerazione.
La ceramica acroma di uso domestico(dove anche le ceramiche di
Nocera Umbra e Castel Trosino sembrano appartenere a questa
categoria, nonostante il loro uso funerario) costituisce la
maggioranza della ceramica dei secoli VI-VII. Essa si presenta
sempre acroma, in terracotta chiara e rossastra con scanalature
più o meno minute su tutta la superficie esterna o su parte di
essa
(6) .
Le forme non offrono molte varianti: boccaletti su basso piede a
larga imboccatura; con alto labbro svasato. Comunque la
granulosità di impasto e la mancanza di sequenze tipologiche
sembrano essere una caratteristica quasi esclusiva delle ceramiche
rappresentate nelle due necropoli longobarde, per le quali sembra
impossibile l'esistenza di un artigianato specializzato.
Due grandi produzioni quindi in ambiente italiano: il nuovo tipo
rappresentato dall'invetriata e il vecchio, che non ha niente a
che fare con questa nuova classe, ma anzi segue la scia, senza
soluzioni di continuità, iniziata nel IV secolo, perpetuando forme
e tecniche di una ormai svuotata tradizione.
Ma quale era veramente la situazione della ceramica longobarda ?
Dopo il loro ingresso in Italia, e già prima in Pannonia, i
Longobardi abbandonano l'agricoltura nelle mani dei popoli
sottomessi, subendo, come conseguenza, la scomparsa della ceramica
nord-danubiana rurale, lavorata a mano, che viene sostituita da
ceramica lavorata al tornio. Il periodo pannonico è, al riguardo,
molto illuminante: costituisce, infatti, il momento di una
coscienza tecnica che si concretizzerà nel potenziamento di una
propria economia artigianale, prima inesistente. Nel loro
movimento verso l'Italia, quindi, i longobardi portarono con sè
quegli artigiani ceramisti, i soli che producevano oggetti
necessari alla loro vita.
La ceramica pannonica (quella immediatamente precedente alla
fase italiana) risulta infatti presente in Italia almeno in un
primo momento. Questo tipo di ceramica era nero o grigio con
stampigliature, su forme essenzialmente biconiche, lavorata al
tornio e acquisita certamente da altri popoli germanici.
Se seguiamo gli stanziamenti longobardi, la troviamo, in
quantità massiccia, a Cividale, la più antica
necropoli
longobarda
(7) ,e a Testona.Si riduce a due soli esemplari a Nocera
Umbra (vasetti delle tomba 148) e scompare del tutto a Castel
Trosino. Probabilmente, non trovando riscontro in alcuna
tradizione nè longobarda nè italica, fu destinata ad
esaurirsi
presto.
Nocera Umbra e Castel Trosino, invece, testimoniano una
persistenza del tipo non decorato, in forma ollare monoansata (con
le dovute eccezioni) e di fattura rozza, rivelando da parte
dell'artefice la conoscenza tipologica ma non quella tecnica. Non
avendo confronti con forme romane contemporanee, si tenta di
considerarla come una produzione ceramica autonoma degli
stanziamenti longobardi in Italia.
Il quadro sopra presentato sembra indicare, in conclusione, una
generale tendenza, in ambiente longobardo, ad accogliere
passivamente forme esterne o a rifornirsi sulla produzione
locale. Non manca tuttavia la volontà di continuare forme
tradizionali, già in uso nella patri pannonica, accentuata ancor
più dalle pratiche funerarie di per sè conservatrici, e del
tutto diverse dalle pratiche della popolazione romana.
L'adozione, tra la ceramica italica, del tipo acromo o con
semplice ingubbiatura rispetto alla ceramica invetriata, potrebbe
spiegarsi con il tentativo di avvicinarsi il più possibile ad un
tipo tradizionale.

CERAMICA INVETRIATA ALTOMEDIOEVALE
Tempo fa, prima della chiusura di alcune sale che le
contenevano, erano esposte, sempre nel Museo dell'Alto Medioevo8,
alcune ceramiche rinvenute nel corso di vecchi scavi nell'area del
Foro Romano (Pozzo H, Colonne Onorarie), le quali documentano le
principali produzioni fittili di Roma nel Medioevo. La classe più
nota e più tipica è quella rappresentata dalla
ceramica
invetriata, detta "a vetrina pesante" o "FORUM WARE", molto comune
a Roma (che ne fu uno dei principali centri produttori) e nel
circondario, ma attestata abbastanza ampiamente anche nel resto
della penisola e nelle isole (vedremo poi che toccherà anche terre
non italiane).
La forma più frequente è la brocca con collo sviluppato,
corpo
ovoidale, beccuccio ad ansa, ma non mancano altre forme come
l'olla, il vaso ad alto collo, i coperchi ed anche le forme aperte
(catini).
In moltissimi esemplari ricorre una decorazione a petali
applicati, disposti in maniera più o meno regolare; numerosi sono
anche i casi di decorazione incisa che può trovarsi talvolta
combinata con la decorazione precedente. Sicuramente attestata nel
periodo carolingio (tardo VIII-IX secolo), grazie alle suddette
caratteristiche, rimane tuttavia ancora aperto il problema della
cronologia iniziale: i dati di scavo finora disponibili non hanno
permesso di chiarire in modo definitivo se sussista un effettivo
rapporto di continuità tra questa produzione e quella tardo
antica; da quest'ultima, comunque, la "Forum Ware" altomedioevale
ha mutuato, non si sa se per tradizione diretta o tramite la
mediazione bizantina, l'elemento decorativo a petali applicati a
rilievo
(9)
Recentemente il Whitehouse
(10) ,in una giornata di studio dedicata
alla ceramica invetriata tardo romana e altomedioevale, ha
sottolineato come una revisione di vecchi rinvenimenti del Lacus
Juturnae (fontana del II secolo a.C. nel Foro Romano) e
soprattutto una nuova valutazione delle monete rinvenute presso la
Fonte, suggerisca la possibilità per il tipo "Forum Ware" di una
datazione anteriore all'anno 600, invece di quella finora proposta
fra il 750 e l'850 ca.
(11)
Ciò sembra capovolgere la tesi sulla continuità
della
invetriata, anche se i ritrovamenti di Castelseprio e di altre
località lombarde, sembrano indicare che nell'Italia
settentrionale la produzione proseguì almeno nel VI e VII secolo:
gli scavi di Luni, con il suo ampio materiale, dimostrano che la
ceramica invetriata tardoromana non fu mai comune nel Levante come
lo era nel Ponente
(12) .
Comunque l'analisi storica generale porta ormai a credere che
nella transizione dalla tarda antichità all'altomedioevo non si
è
verificata nessuna perdita delle abilità artigianali, ma solo una
riduzione della quantità degli artigiani specializzati in un mondo
in cui poche persone potevano permettersi di pagarli
adeguatamente.
Resta comunque il fatto che una diffusione nell'uso delle
ceramiche rivestite con vetrina piombifera si ebbe solo dopo il
1000. Fino al secolo XII il livello del corredo domestico in
ceramica, rimase qualitativamente e quantitativamente molto basso,
probabilmente in rapporto con un maggiore impiego di recipienti in
altri materiali, pietra ollare e vetro, trovati in strati
altomedioevali, e che hanno anche riscontri in documenti scritti
nei secoli XII e XIII.
Consideriamo la sua distribuzione. Se guardiamo tutte le
attestazioni di ceramica a vetrina pesante altomedioevali,
apparirà evidente la diffusione relativamente ampia di queste
produzioni, anche se quantitativamente esigue (ad eccezione di
Roma e del Lazio), riferibili a diversi centri di origine.
Elementi sufficienti per una datazione circostanziata sono
emersi finora solo a Roma,nello scavo della Crypta Balbi
(13) ,dove
la ceramica a vetrina pesante altomedioevale, nta anche con il
nome di "Forum Ware" è già presente in strati di VII
sec.
inoltrato in associazione con un altro tipo di invetriata, di
produzione locale, la quale presenta caratteri molto simili
all'invetriata bizantina di VII-VIII sec., di cui costituisce
probabilmente una filiazione diretta.
Si tratta di una ceramica ad impasto grezzo, superfici
schiarite, invetriatura esclusivamente interna, spessa, brillante,
di colore chiaro o marrone-verdastro, cavillato.
Non sappiamo esattamente quando tale produzione abbia avuto
inizio a Roma, ma essa è certamente posteriore alla diffusione
della ceramica invetriata in area bizantina, avvenuta nella prima
metà del VII, da cui mutua le caratteristiche di fondo
(14) .
Da ciò si deduce che questa ceramica, che deve essere
considerata la prima produzione invetriata altomedioevale di Roma,
si colloca nei secoli centrali dell'VIII sec. esattamente
nell'ambito cronologico indicato dalla stratigrafia della Crypta
Balbi.
Numerosi ritrovamenti in siti anche molto distanti (il caso di
Marsiglia e di Genova è emblematico), sono ricondicibili alla
tipologia romana e provengono, con ogni probabilità, da officine
di Roma. Rientrano in questo gruppo alcuni frammenti di Napoli,
della Sardegna,della Corsica, probabilmente anche un frammento di
Arezzo: in Toscana, oltre questo frammento, sono tornati alla luce
di recente alcuni pezzi di ceramica a vetrina pesante a Lucca
(15)
e a rocca S.Silvestro,riferibili, forse, a centri di fabbricazione
di area toscana, anch'essi non ancora localizzati. La
distribuzione dei ritrovamenti, come risulta dalle località
citate, è prevalentemente, ma non esclusivamente, costiera:
l'irraggiamento della produzione romana di ceramica a vetrina
pesante lungo le coste tirreniche (da Napoli a Genova e Marsiglia,
coste della Sardegna e della Corsica) documenta, sul piano
archeologico, il persistere di contatti lungo collaudate rotte
marittime, concordemente con quanto è noto dalle fonti
altomedioevali. Vediamo come esempio il caso di Marsiglia.
In questo luogo, negli scavi del 1985, furono rinvenuti pezzi di
ceramica a vetrina piombifera verde. Messi a confronto con quelli
provenienti dallo scavo della Crypta Balbi
(16) , lo studio ha
provato l'origine comune dei frammenti di Roma e Marsiglia, e
dunque l' esportazione in Francia meridionale di prodotti
nvetriati del Lazio. Questo commercio ipotizzabile già nel IX
secolo, riguarda principalmente i secoli X-XI. Per ora dunque,
la ceramica a vetrina pesante rappresenta la più antica
ceramica medioevale d' importazione scoperta in Francia
meridionale.
Nel suo complesso, la distribuzione della ceramica a vetrina
pesante altomedioevale in confronto a quella invetriata tardo-
antica mostra uno spostamento dell'asse dal settentrione della
penisola, dove l'invetriata era prevalente in periodo tardo-
antico, al centro sud in periodo altomediovale. Ed è proprio
quest'ultima parte d'Italia che rimane in stretto contatto con il
mondo bizantino nei secoli VII e VIII, da cui sembra derivò motivi
di sopravvivenza "ellenistica".
Nel corso del X secolo la ceramica a vetrina pesante subisce
delle radicali trasformazioni: da una parte un impoverimento del
rivestimento, distribuito da ora in modo assai irregolare
sull'intera superficie del vaso (ceramica a vetrina pesante a
macchia o "Sparse Glazed"); dall'altra una modificazione di
carattere formale, con l'affermarsi del vaso biconico con
beccuccio espanso.
Il suo esaurimento si colloca in un periodo successivo,
pressapoco nei secoli XII-XIII, soppiantato dalla diffusione,
abbastanza considerevole anche a Roma, di ceramiche rivestite di
tipo bassomedioevale. Gli ultimi esemplari di ceramica a vetrina
pesante, consistono in vasi che presentano appena una pennellata
intorno a tutto il corpo (ad esempio gli esemplari di S.Cornelia).
Accanto alla ceramica a vetrina pesante, furono prodotti a Roma
per tutto il Medioevo altri tipi di ceramica, quali la ceramica da
fuoco e quella ad impasto depurato, prive di rivestimento
(ceramiche acrome). Al primo tipo appartengono olle, boccali,
tegami, coperchi e lucerne. Ad eccezione del tegame, gli esemplari
esposti sono riferibili ai secoli antecedenti il Mille.
Interessante è notare come il vasellame fabbricato a Roma nei
primi secoli del Medioevo, contrariamente ad altre zone, presenti
un livello tecnologico evoluto: i vasi sono sempre lavorati al
tornio veloce, gli impasti accuratamente selezionati, le superfici
ben definite.
Anche la ceramica acroma ad impasto depurato rivela,
nell'Altomedioevo, una vasta gamma di tipi e decorazioni. Le forme
più comuni sono rappresentate da brocche e anfore di varie
dimensioni. L'esemplare monoansato si riallaccia alla tradizione
tardo-antica, mentre le anfore a corpo ovoidale, spesso con
decorazione a linee ondulate eseguite a pettine sulla spalla, sono
comuni nei secoli VIII-IX.
Un'altra forma tipica del periodo è l'anforetta a largo collo
svasato, sulla cui superficie schiarita compaiono decorazioni
incise a pettine o a rotella.
Le ceramiche da mensa di tipo bassomedioevale, si affermano a
Roma solo nel XIII secolo, sotto l'influsso di ceramiche importate
già nel XII secolo da altri centri mediterranei, soprattutto
dall'Italia meridionale.
Le nuove tecniche, che introducono un rivestimento invetriato o
smaltato monocromo (verde o giallo) o policromo (verde, bruno,
giallo) su fondo bianco, si trovano applicate inizialmente alle
sole forme chiuse (boccali e "truffette" ovvero boccali panciuti a
collo strettissimo e orlo trilobato), e solo successivamente
estese a forme aperte (ciotole carenate e catini)
(17) .
NOTE
(1)
I. BALDASSARRE, La ceramica delle necropoli di Nocera Umbra e
Castel Trosino, Altomedioevo I-1967, pp.141-185
(2)
A. PASQUI-R. PARIBENI, La nacropoli barbarica di Nocera Umbra,
Mon. Ant. Linc. XXV-1918, pp.137-351; R. MENGARELLI, La necropoli
barbarica di Castel Trosino presso Ascoli Piceno, Mon. Ant. Linc.
XX-1902, pp.47-235
Nell'anno 571 la città fu conquistata dai longobardi e
incorporata nel Ducato di Spoleto.
(4)
La città posta sulla Via Salaria presso Ascoli Piceno fu
conquistata dai longobardi nel 578 ed in seguito inclusa nel
Ducato di Spoleto.
(5)
O. MAZZUCATO, La ceramica laziale nell'altomedioevo, Roma
1977, nn.53-54, dove recipienti simili, ma in realtà più
tardi,
vengono indicati con questo nome.
(6)
Per Ventimiglia cfr. il lavoro di N. LAMBOGLIA, Ventimiglia
romana, Bordighera 1964
(7)
Cfr. M. BROZZI, La più antica necropoli longobarda in Italia,
Nocera Umbra s. d.
(8)
Esattamente nella vetrina 23.
(9)
È da ricordare che nei secoli VIII-IX, una copertura molto
simile alla vetrina pesante è in uso a Bisanzio, per cui è
logico
supporre che vi sia stato un legame tra il " vetro romano"
occidentale e quello prodotto nell'Impero romano d'Oriente. Cfr.
O. MAZZUCATO, Introduzione alla Ceramica Medioevale del Museo di
Roma, Roma 1990, p.9
(10)
D. WHITEHOUSE, L'invetriata tardo romana e altomedievale nel
Lazio, Atti del Convegno "La ceramica invetriata tardoromana e
altomedievale" (Como, 14 Marzo 1981), Como 1985, pp.105-108
(11)
O. MAZZUCATO, La ceramica a vetrina pesante, Roma 1972
(12)
H. BLAKE, Ceramiche romane e medioevali e pietra ollare dagli
scavi della torre civica di Pavia, Archeologia Medioevale V-1978,
pp.141-170
(13)
Il giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa,
Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi .3, a
cura di D. MANACORDA, Firenze 1985; L'esedra della Crypta Balbi
nel Medioevo (XI-XV sec.), Archeologia urbana a Roma: il progetto
della Crypta Balbi .5, a cura di L. SAGUI' e L. PAROLI, Firenze
1990
(14)
Non sembra perciò affatto sorprendente che il più antico
tipo
di ceramica invetriata altomedioevale prodotto a Roma negli anni
centrali dell'VIII sec. abbia elementi in comune con quella in uso
a Costantinopoli, e che molti tratti bizantini si ritrovino ancora
nei primi esemplari del "Forum Ware". Cfr. Atti del Convegno "La
ceramica invetriata...", op. cit.
(15)
G. DE MARINIS, Esemplari di ceramica invetriata altomedievale
a Lucca, Archeologia Medioevale V-1978, pp.504-512
(16)
Il giardino del Conservatorio..., op. cit.
(17)
Su tutti gli argomenti trattati nell'articolo vedasi anche la
seguente bibliografia: ENCICL. ARTE ANTICA, vol. III, s. v.
Ceramica e Suppl., Atlante della ceramica romana, Roma 1983; B. M.
FELLETTI MAJ, Echi di tradizione antica di età longobarda in
Umbria, Atti del II Convegno di Studi Umbri, Gubbio 1974, p. 317
sgg.; O. MAZZUCCATO, La ceramica a vetrina pesante, Roma 1972; A.
MELUCCO VACCARO, I Longobardi in Italia. Materiali e problemi,
Milano 1982; S. NEPOTI, Manufatti di uso domestico, Archeologia
Medioevale X-1983, pp. 199-212; L. PAROLI, Ceramiche a vetrina
pesante scoperte a Roma e a Marsiglia: risultati delle prime
analisi fisico-chimiche, Archeologia Medioevale XIII-1986, pp. 79-
86; L. PAROLI, D. MANACORDA, M. RICCI, A. MOLINARI, D. ROMEI, La
ceramica medioevale di Roma nella stratigrafia della Crypta Balbi,
Atti del III Congresso Internazionale "La ceramica medioevale nel
Mediterraneo Occidentale" (Siena-Faenza, 8-13 Ottobre 1984),
Firenze 1986, pp. 511-544; La ceramica invetriata tardo antica e
altomedievale in Italia, a cura di L. PAROLI, Atti del Seminario
(Certosa di Pontignano-Siena, 23-24 Febbraio 1990), Firenze 1992;
A. PERONI, L'arte in età longobarda. Una traccia, Magistra
Barbaritas, Milano 1984, pp. 229-300; O. von ESSEN, A proposito
della ceramica longobarda in Italia, Atti del Convegno di Studi
Longobardi 1970, pp. 91-94; O. von ESSEN, A proposito della
produzione di ceramica nel periodo delle migrazioni, XVIII Sett.
Studi Alto Medioevo, Spoleto-Cen. It. Stud. Alt. Med. 1971, pp.
749-764; O. von ESSEN, Il cimitero altomedievale di Pettinara
Casale Lozzi (Nocera Umbra), Firenze 1978; O. von ESSEN, Alcuni
aspetti della cronologia riguardante i Longobardi in Italia, Atti
del VI Conv. Intern. Stud. Alto Med., Spoleto 1980, pp. 229-300;
D. WHITEHOUSE, Nuovi elementi per la datazione della ceramica a
vetrina pesante, Archeologia Medievale, VIII-1981, p. 583 sgg.